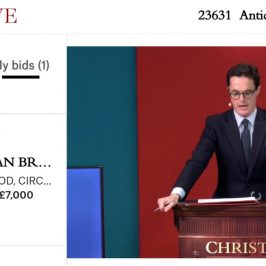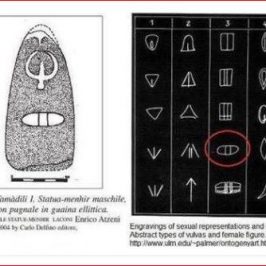di Silvano Tagliagambe 
- Primo e fondamentale presupposto: definire correttamente cosa si intende per “identità”
Se si vuole impostare oggi un discorso serio sull’identità del popolo sardo, sul suo significato da un punto vista non solo culturale, ma anche politico, e sull’incidenza che può avere sulla sua definizione la civiltà nuragica bisogna partire innanzi tutto da un aperto e coraggioso riconoscimento della situazione del recente passato che, per alcuni aspetti, permane anche oggi.
Gli studi di Nereide Rudas e di Placido Cherchi sono, a mio avviso, un punto di partenza dal quale non si può prescindere a tal fine: essi ci dicono che una delle cifre più individuanti della cultura sarda e del senso d’identità che la caratterizza è la depressività, vale a dire lo stato di demotivazione e di sottostima, e che il mondo identitario dei sardi è esposto come una sorta di malattia mortale alla folklorizzazione dello specifico e alla vergogna di sé. La conclusione, difficilmente contestabile, che se ne può trarre è che questo substrato emotivo ha condizionato in maniera tutt’altro che irrilevante i processi cognitivi di valutazione dell’esperienza in atto e il tipo di atteggiamento che ha caratterizzato anche le scelte e le decisioni politiche.
Se si concorda con questa premessa condizione imprescindibile per avviare un miglioramento della qualità della politica e incrementare il livello di partecipazione e di coinvolgimento dei cittadini non solo per quanto riguarda gli appuntamenti ai quali sono chiamati a rispondere, come quelli elettorali, ma soprattutto per ciò che concerne l’intera fase dei processi decisionali che la caratterizzano, a monte e a valle di quegli appuntamenti, è un rovesciamento di prospettiva che prenda avvio da una diversa consapevolezza, da parte del popolo sardo, di sé, del proprio passato e delle prospettive future.
Quanto questo ribaltamento possa incidere sul presente ce lo dicono i risultati attuali della ricerca scientifica in tutti i campi. Già nel 1973 Konrad Lorenz ha sostenuto che il processo filogenetico di trasmissione dell’informazione dal patrimonio di conoscenze accumulato dalla specie nel corso del suo sviluppo ai singoli individui che ne fanno parte sia segnato dall’ Aἰών, che garantisce la continuità tra le diverse generazioni. Questa idea viene oggi corroborata dalle ricerche delle neuroscienze, che evidenziano come ciò che chiamiamo “esperienza” si strutturi in virtù della disponibilità di “guide innate per l’apprendimento” risalenti a una memoria profonda, che ha i tempi lunghi della storia naturale e non quelli brevi dello sviluppo individuale. Ciò pone al centro dell’attenzione l’impossibilità di ridurre la memoria a un archivio di ricordi, chiuso e risolto nella dimensione di ciò che è stato e non è più, e l’esigenza di considerarla l’incarnarsi del «qui» e «ora» in un processo di lunga durata, che si rivela infinitamente più significativo della mera empiricità del tempo cronologico e rende permeabile la relazione tra le tre dimensioni nel quale esso tradizionalmente si articola. Se tutto questo è vero fare i conti con il proprio passato (catarsi), anche quello più remoto, non è un esercizio astratto da riservare agli studiosi e agli specialisti ma è una premessa indispensabile per vivere il presente con maggiore consapevolezza e con una maggiore profondità di valutazione e di visione.
Un altro elemento da considerare e sul quale lavorare è il modo di intendere l’identità dei soggetti individuali e collettivi. Considero imprescindibile, a questo proposito, il riferimento a un’opera del 1984 di Dereck Parfit, dal titolo Reasons and Persons. In questo suo saggio l’autore prende avvio dall’idea che ciò che è veramente ciò che chiamiamo “identità” può essere più facilmente compreso “se suddividiamo la vita di una persona in quella di molteplici io” successivi e coesistenti. Per calarsi in un contesto del genere basta pensare, ad esempio, a situazioni nelle quali si verifichi una marcata attenuazione della connessione psicologica tra le diverse fasi o i diversi aspetti della nostra esistenza. “Una volta che tale attenuazione abbia avuto luogo, il mio io precedente può sembrare estraneo al mio io attuale e se questo non si identifica con quello, in qualche modo io penso quello come una persona diversa da me. Qualcosa di simile possiamo dire dei nostri io futuri”[1].
Posta in questi termini la questione dell’identità personale può dunque essere vista come il problema dei rapporti tra più stadi-persona, per cui ciò che comunemente chiamiamo “persona” risulta essere un processo, un succedersi di eventi (person-stages). In questo quadro l’identità può essere considerata come la soluzione di un problema che può essere formulato nei termini seguenti:
“come possiamo affermare che Y nell’istante di tempo T2 è identico a X nell’istante precedente T1?”.
Per risolvere questo problema occorre preliminarmente distinguere fra due diversi significati possibili del termine “identità”: l’identità qualitativa, con la quale si indica il rapporto fra due entità qualitativamente identiche, e quella numerica, con cui ci riferiamo al fatto che due entità, osservate in istanti di tempi diversi, pur non essendo identiche sotto il profilo qualitativo sono tuttavia la stessa entità. Possiamo, ad esempio, dire di una persona: “Dopo l’incidente non è più la stessa”. Questa affermazione riguarda entrambi i tipi di identità. Quel che diciamo è che la persona, pur essendo di fatto la stessa, ora non appare più quella di prima. Non siamo affatto in presenza di una contraddizione. Quel che intendiamo dire è semplicemente che il carattere di questa persona è cambiato; una persona numericamente identica ora è qualitativamente diversa.
Secondo Parfit il tipo di identità che è effettivamente in gioco nelle questioni concernenti l’identità personale è sicuramente il secondo, cioè quello numerico, in quanto è in riferimento a esso che ci si può chiedere se e in che misura stadi-persona diversi siano riconducibili ad una stessa entità. A questo riguardo in Reasons and Persons viene proposta la formula seguente:
Y in T2 è identico a X in T1 se e solo se:
- Y in T2è continuo con X in T1;
- questa continuità ha un certo tipo di causa oppure ogni causa può essere considerata come valida (vi sono differenti versioni di questa formula);
- questa continuità non ha assunto una forma “ramificata”, tale da creare situazioni di intransitività.
Una proprietà importante del concetto di identità è infatti quella di transitività: se A è identico a B e quest’ultimo a C, ne segue che lo stesso A deve essere identico anche a C.
Ora le condizioni 1 e 2 non sembrano sollevare difficoltà particolari, mentre le terza (“nobranching condition” , cioè condizione di non ramificazione) si scontra con i problemi sollevati da alcune malattie cerebrali, in particolare dalla split brain syndrome, descritta da Sperry e Gazzaniga[2]. Si tratta di un caso estremo delle “sindromi da disconnessione”, che risulta dalla sezione chirurgica della principale commessura esistente fra i due emisferi del cervello, il corpo calloso. Lo studio attento dei pazienti con split brain sembra suffragare l’ipotesi che in questi soggetti vi siano due flussi separati di coscienza. Questo dato emerge chiaramente nel corso di alcuni esperimenti appositamente studiati e realizzati, ma è probabilmente un dato costante nella vita psichica di questi soggetti, anche se il loro comportamento globale non mostra anomalie grossolane. In questi casi se chiamiamo B e C i due processi mentali indipendenti che emergono dopo l’intervento e A il sistema mentale del soggetto prima di quest’ultimo, si realizza una situazione del tipo A=B e A=C, il che è assurdo, se assumiamo che B sia diverso da C. Ne deriva l’impossibilità di operare la reidentificazione in conformità alla condizione 3.
Se rifiutiamo il concetto di “sostanza mentale” come fondamento dell’identità personale e adottiamo una prospettiva “riduzionista” possiamo appellarci a due possibili criteri di reidentificazione: un criterio fisico e un criterio psicologico. Il primo fa appello, come condizione necessaria per reidentificare Y in T2 con X in T1, alla continuità fisica del corpo e del cervello. Attualmente, però questa condizione appare troppo forte e non necessaria, dato che le crescenti possibilità nel campo dei trapianti di organi evidenziano che la continuità del corpo nella sua interezza non costituisce certamente un presupposto senza il quale non si possa dare la reidentificazione e che il punto effettivamente rilevante è la continuità del cervello. E, d’altro canto, per quanto riguarda specificamente quest’ultimo, l’esperienza quotidiana nei reparti neurologici dimostra che anche ampie lesioni distruttive dell’encefalo sono compatibili con la conservazione dell’identità personale.
Tenendo conto di queste precisazioni il criterio fisico assume dunque la forma seguente: “Y oggi è la stessa persona di X nel passato se e solo se una quantità sufficiente del cervello di X continua a esistere e se questa continuità non ha assunto una forma ramificata”. Ma anche questa versione debole del criterio fisico va incontro a obiezioni significative. Come rileva infatti Defanti[3], il riferimento a “una quantità di cervello sufficiente per essere il cervello di una persona vivente” è opinabile e si mostra carente per quanto riguarda la possibilità effettiva di fare da supporto all’identità personale. Basta, per convincersene, pensare a una condizione morbosa quale lo Stato Vegetativo Persistente (Svp), nel quale manca qualsiasi attività mentale riconoscibile. Ma a parte ciò, vi sono altre obiezioni, come quella che emerge dall’esperimento mentale del “brain zap” proposto da J. Perry[4], che postula la possibilità di cancellare completamente, mediante un’opportuna tecnologia, i ricordi di una persona senza danneggiarne il cervello, allo stesso modo in cui si cancellano, ad esempio, i dati immagazzinati su un supporto magnetico. Commenta Defanti: “In questo caso è evidente che il criterio fisico di identità personale fallirebbe; la continuità fisica non assicura la conservazione dell’identità personale. In realtà questo esperimento, ancorché teoricamente interessante, non è biologicamente realistico: non è verosimile che si possano cancellare i ricordi di una persona senza alterare, anche se in modo lieve (ultrastrutturale), il cervello. L’esperimento sembra comunque dimostrare un punto cruciale: non è sufficiente che vi sia continuità di (parte del) cervello e che il cervello sia capace di fungere da base di stati mentali; è altresì necessario che siano conservati (parte dei) ricordi propri della persona. Formulato in questo modo, il criterio fisico si avvicina moltissimo al criterio psicologico” [5].
Quest’ultimo criterio viene definito da Parfit attraverso il riferimento a due tipi di relazione:
- a) la psychological connectedness (connessione o concatenazione psicologica) che indica il persistere di nessi psicologici diretti fra X e Y;
- b) la continuità psicologica, che è il verificarsi di catene embricate di connessioni grazie alle quali sussistano sufficienti collegamenti diretti tra una fase e l’altra.
Sulla base di queste definizioni preliminari Parfit così definisce il criterio psicologico: “(1) c’è continuità psicologica se e solo se ci sono catene intercollegate di connessioni forti. X oggi è la medesima persona che Y era in un momento passato se e solo se (2) X è in continuità psicologica con Y, (3 ) tale continuità ha il giusto tipo di causa, e (4) non esiste un’altra persona che sia anch’essa in continuità psicologica con Y. (5) L’identità personale nel tempo consiste proprio nel ricorrere di fatti come (2), (3) e (4).
Del criterio psicologico ci sono tre versioni che si differenziano in rapporto al problema di quale sia il giusto tipo di causa. Secondo la versione rigida, essa dev’essere la causa normale. Secondo la versione ampia può essere una qualsiasi causa attendibile. Secondo la versione amplissima, può essere una causa qualsiasi “[6].
Se ci si riferisce alla causa normale, il criterio psicologico non è lontano dalla versione “sofisticata” del criterio fisico, in quanto questo tipo di causa si identifica, sostanzialmente, con l’esistenza continuata del cervello. Se invece, come Parfit fa, si assume che ogni tipo di causa sia valido, per cui l’identità personale potrebbe essere mantenuta anche dopo un ipotetico esperimento di “teletrasporto”, nel quale il cervello e il corpo sarebbero distrutti per essere poi ricostruiti, in una replica esatta, in un luogo diverso, per esempio in un altro pianeta, il criterio in questione rappresenta una grossa rottura con il senso comune.
È importante notare, in via preliminare, che l’identità personale, intesa in questo senso, non conosce salti, per cui secondo Parfit non è corretto affermare (in termini tutto-o-niente) che c’è o non c’è, che la si possiede oppure no. Essa è, invece, una questione di gradi: fra gli stadi successivi di una stessa persona (fra “me” come sono oggi e un “me futuro”) possono cioè sussistere legami più o meno forti. Da questo punto di vista possiamo vivere il rapporto tra il mio «io» di oggi e quello di ieri o di domani alla stessa stregua e con le medesime modalità di come viviamo la relazione tra me e un’altra persona qualsiasi. Dunque, in questa prospettiva, ciò che chiamiamo «io» non è un’entità singola e indivisibile, ma un soggetto collettivo, proprio come lo sono lo Stato, la Nazione, la Chiesa, il Partito, ecc., che si costituisce come collezione di elementi diversi, a ciascuno dei quali corrisponde, come detto, una fase o un aspetto della mia vita. E come non ha senso dire che “Tutti i parenti di una persona sono ugualmente suoi parenti” o che “Tutte le parti della storia di una nazione sono ugualmente parti della storia di questa nazione” o, ancora, che all’interno di qualunque soggetto collettivo (ad esempio lo Stato), i rapporti che sussistono fra gli individui che ne fanno parte, e cioè i cittadini, sono tutti ugualmente stretti, così, una volta che si sia convenuto che anche l’«io» è un soggetto collettivo, non pare ragionevole asserire che i nodi che compongono la sua complicata rete debbono essere collegati da archi di uguale peso e importanza. Appare anzi come un obiettivo che non può in nessun modo essere dato per scontato, ma che va invece perseguito con il massimo impegno, quello di conferire il più alto grado possibile di omogeneità a questo insieme, facendo in modo che tra le sue parti si stabiliscano la massima estensione e il più elevato grado possibile di connessione e di continuità. Solo in questo modo quel particolare soggetto collettivo che è l’ «io» potrà acquisire un buon livello di stabilità e un soddisfacente equilibrio.
2. Secondo presupposto: il ripensamento del linguaggio e delle sue funzioni
L’importanza di questo approccio consiste nel fatto che equipara, almeno da un punto di vista concettuale, il problema della costruzione e dello sviluppo di un soggetto individuale alla interazione che si sviluppa all’interno dei soggetti collettivi e della comunità, Il primo passo che deve essere compiuto per muoversi con efficacia in questa direzione è un ripensamento del linguaggio e delle sue funzioni che prenda atto del fatto che esso non è uno strumento per convogliare informazioni su una realtà oggettiva indipendente dall’atto del parlare, a cui si riferirebbe, in quanto non esiste un punto di vista esterno e “assoluto” dal quale effettuare “osservazioni” e “descrizioni”. Queste ultime, come osservano in particolare Terry Winograd e Francisco Flores, vengono prodotte all’interno di un dominio da un osservatore e rivolte a un altro osservatore, che costruisce con lui un dominio di condotte reciprocamente intrecciate (il cosiddetto “dominio consensuale”, che viene continuamente rigenerato dall’attività linguistica degli individui che compongono una comunità). Da questo punto di vista il linguaggio “è una modellizzazione del ‘comportamento di orientamento reciproco’ e non un insieme di meccanismi in un ‘utente del linguaggio’ o un ‘accoppiamento semantico’ tra un comportamento linguistico e perturbazioni non linguistiche di cui gli organismi fanno esperienza”[7].
La sua funzione connotativa orienta un campo di cooperazione e di interazioni, all’interno del quale un sistema cognitivo cerca di dare un senso alle cose. Questa natura eminentemente sociale del linguaggio esclude ogni rischio di solipsismo o di negazione della possibilità di una conoscenza oggettiva e della sua trasmissibilità, come gli stessi Winograd e Flores sottolineano riprendendo un passo di Maturana: “Le differenze culturali non rappresentano modi diversi di trattare la stessa realtà oggettiva, ma domini cognitivi legittimamente differenti. Uomini diversi culturalmente vivono in realtà cognitive diverse che sono ricorsivamente specificate attraverso il loro vivere in esse […] La questione del solipsismo nasce soltanto come pseudo-problema, o non nasce affatto perché la condizione necessaria per la nostra possibilità di parlarne è il nostro avere un linguaggio come sistema consensuale di interazioni in un dominio cognitivo dipendente dal soggetto, e questa condizione costituisce la negazione del solipsismo”[8].
Riprendendo e facendo propri alcuni spunti del pensiero di Heidegger, Winograd e Flores sottolineano che il rapporto che ciascun soggetto, individuale o collettivo, ha con le cose con le quali entra in contatto non ha affatto bisogno di mediazioni e mediatori, perché è qualcosa di originario, determinato dall’appartenenza a uno specifico contesto che non è stato scelto, ma in cui ci si trova “gettati” e di cui si deve costantemente tener conto. Cruciale, da questo punto di vista, è la distinzione heideggeriana tra vedere e guardare . Non è il vedere in se stesso ad avere un senso e soprattutto a dare un senso alle cose, ma il guardare, che significa inquadrare un oggetto come funzione del mio mondo, che ha senso in relazione al mio vivere. Quando guardo nel senso heideggeriano guardo sempre una funzione , cioè considero un oggetto in quanto utilizzabile da me all’interno dello specifico ambiente in cui vivo e del modo in cui vivo.
Il senso dipende dunque in modo essenziale dal contesto, in quanto il guardare è contestualmente determinato. Ciò non implica che esso sia arbitrario, poiché dipende strutturalmente dalle regole del gioco che vigono all’interno del contesto medesimo. In questo quadro la descrizione dell’essere nel mondo deve necessariamente partire dai dati originari e costitutivi fornitici dalla nostra presenza in esso. Essere nel mondo è essere e agire in un contesto, ma non come soggetto passivo, bensì come agente capace di progettare in vista di determinati fini che ci si propone di conseguire. Il contesto è dunque già definito, non è creato da noi, in quanto siamo gettati in una situazione che non abbiamo scelto (Dasein = esserci, nel senso, appunto, di essere gettati): e di questa situazione dobbiamo prenderci cura , conferendo ad essa la rilevanza che merita dato il suo carattere di imprescindibilità. Questo prendersi cura del mondo è dunque la relazione primordiale con esso, il punto di partenza che non possiamo eludere. E tuttavia, questo mondo in cui siamo gettati rende possibile una non fittizia libertà di azione. Presupposto di quest’ultima è la capacità di prendere le distanze dal contesto in cui si vive attraverso il disallontanamento , cioè la tensione orientata verso il raggiungimento di qualcosa che non è qui, non è già disponibile, che è lontano. In virtù di questa riorganizzazione di distanza dal contesto diveniamo via via capaci di ricostruire quest’ultimo in relazione a una specifica esigenza e di vederlo in connessione con un determinato progetto: questo è il senso ontologico della nostra possibilità di comprensione del mondo.
3. Terzo presupposto: il nesso inscindibile tra il cervello e il ”suo” ambiente
Questa dipendenza del senso delle parole che usiamo dal contesto è oggi oggetto di una specifica attenzione e trattazione anche da parte della fisica, in particolare della teoria quantistica dei campi, la quale propone un modello del cervello. A questa fondamentale questione si propone di fornire una risposta il modello del cervello caratterizzato dall’idea che la relazione tra i nostri processi cerebrali e il nostro mondo sia un costante processo dinamico di raddoppiamento, nel quale l’azione osservata e l’azione eseguita sono strutturalmente equivalenti, per cui tutto ciò che sembra statico e “sostanziale” (il cervello dissipativo, i suoi oggetti come “cose”) emerge in realtà come effetto di equivalenze da questo processo dinamico di rispecchiamento reciproco e coevolutivo. È per questo importante sintetizzarne gli aspetti fondamentali.
L’aspetto di questo modello che ci interessa ai fini della vexata quaestio del rapporto tra la realtà esterna e i nostri processi mentali è che esso considera il cervello un sistema intrinsecamente aperto, permanentemente accoppiato con l’ambiente esterno. In virtù di questo accoppiamento inscindibile l’ambiente si comporta come il doppio del cervello, nel senso che si comporta esattamente come quest’ultimo per quanto riguarda i flussi di materia, energia e informazione, a patto che se ne inverta la direzione: infatti, ciò che per il cervello è verso l’interno, per l’ambiente è verso l’esterno, e in senso opposto. Chiaramente, invertire la direzione dei flussi equivale a scambiare il cervello con l’ambiente, e viceversa. Poiché tecnicamente la direzione del flusso viene invertita cambiando il segno della variabile tempo, possiamo dire che l’ambiente si comporta come la copia del cervello per la quale è stata invertita la direzione del tempo (la sua copia invertita nel tempo). In sintesi, il sistema che descrive l’ambiente è anche l’immagine del cervello nello specchio del tempo (la sua immagine speculare temporale di A). In altre parole, l’ambiente è il doppio del cervello. Il tempo viene così a svolgere una funzione di primo piano nella impostazione del rapporto tra il cervello e il suo ambiente, proprio perché è solo riferendosi a esso e cambiandone il segno che si può assumere il secondo come doppio del primo, spiegando così quello che secondo la teoria quantistica dei campi è il tratto caratteristico fondamentale dell’incastro tra il corpo di un organismo e il contesto in cui vive.
Per capire questo riferimento all’ambiente come doppio del cervello bisogna, come sottolineano Barkow, Cosmides, Tooby “distinguere ‘l’ambiente’ nel senso del reale stato totale dell’intero universo – che, ovviamente, non è causato dai geni o dai meccanismi di sviluppo di un individuo – da “l’ambiente” nel senso di quei particolari aspetti del mondo che sono resi mentalmente rilevanti per lo sviluppo dalla progettazione evoluta degli adattamenti allo sviluppo di un organismo. È questo ambiente rilevante per lo sviluppo – l’ambiente con cui l’organismo interagisce – che, in un senso significativo, si può dire sia il prodotto dell’evoluzione, evolvendosi di pari passo con la risposta organizzata dell’organismo ad esso. La confusione di questi due sensi ben distinti di “ambiente” ha oscurato il fatto che l’organizzazione ricorrente dell’ambiente contribuisce a un’eredità biologica parallela a quella dei geni, che agisce in modo paritario con essi per evolvere[9].
Occorre, a questo proposito, ricordare che la situazione della biologia contemporanea non è esattamente quella dei tempi di Darwin e c’è una correzione da apportare alla teoria evolutiva. A introdurre il primo e più generale principio di questa correzione è Lewontin, secondo il quale “come non può esistere un organismo senza un ambiente, così non può esistere un ambiente senza un organismo. Si fa confusione tra l’affermazione corretta che esiste un mondo fisico al di fuori di un organismo che continuerebbe a esistere in assenza della specie e l’affermazione errata che gli ambienti esistono senza le specie”[10].
Anche Uexküll[11] sostiene che l’organismo sceglie all’interno dell’ambiente generale gli stimoli che gli sono specifici e rivolge le sue relazioni a determinati caratteri delle cose che lo circondano, comprendendoli in una rete che porta alla sua esistenza. Il suo obiettivo dichiarato è esplicito: mettere in crisi in modo definitivo un pregiudizio antropocentrico, l’idea che le varie specie animali, le meduse e i gatti, i lombrichi e i ricci, vivano in uno spazio senso-motorio identico al nostro, come se le nostre modalità di senso e di azione costituissero il punto di riferimento per la vita di qualunque organismo. Attraverso un continuo lavoro di indagine e di divulgazione Uexküll descrive il modo in cui ogni forma di vita ritaglia il proprio ambiente secondo le strutture percettive e la conformazione che la contraddistinguono: per il cane lo spazio ha innanzitutto una organizzazione olfattiva che struttura il suo ambiente in territori nei quali lasciare tracce odorose; i luoghi sorvolati dalla mosca risentono della particolare morfologia di occhi composti da migliaia di elementi, ognuno dotato di cristallino proprio. Uno stimolo per essere tale non deve solo prodursi ma deve anche essere avvertito, presuppone cioè l’interesse del vivente; dunque, non proviene dall’oggetto ma dalla domanda del vivente. Di tutta la ricchezza di cui un determinato ambiente è costituito, in quanto elargitore di perturbazioni potenzialmente illimitate, l’animale non ritiene che alcuni segnali. Ciò che chiamiamo “ambiente” rappresenta pertanto una selezione di parte dell’intero ambito geografico che solo l’uomo riesce a percepire. Ciò che l’ambiente offre al vivente è funzione della domanda stessa.
In questo quadro di riferimento sistemico, riassumendo:
- L’organismo determina quali parti dell’ambiente saranno messe insieme per creare il proprio ambiente specifico.
- L’organismo costruisce attivamente il proprio mondo, il proprio ambiente.
- Questo rappresenta un processo costante e attivo di alterazione del mondo, per sostenere il processo di vita. L’esempio più semplice è che ogni organismo vivente consuma e produce.
- L’organismo può modulare e regolare costantemente le proprietà statistiche dell’ambiente nel corso del tempo. Questa proprietà mostra l’intelligenza intrinseca della vita.
- Ogni organismo seleziona e interpreta in modo peculiare i segnali fisici che percepisce. È l’assetto dell’organismo a determinare l’esistenza di un mondo specifico e non di un altro. Questa proprietà significa che non solo noi esseri umani, ma tutta la vita biologica ha una natura disposizionale e che ogni specie sul pianeta abita un mondo parzialmente o totalmente diverso[12].
Ogni nicchia coevolutiva umana è anche una nicchia culturale, per cui non si tratta solo di una descrizione biologica, ma di quella che Laland, Odling-Smee e Fekdman[13] chiamano una “prospettiva eco-cognitiva”.
Per questi motivi è ragionevole sostenere che sia una forma aspecifica di plasticità ambientale, sia una rigida predeterminazione genetica sono entrambe astrazioni. Guardando da una prospettiva complementare, sia l’individuo specifico, “unico”, sia l’ambiente sono allo stesso tempo ereditati (predeterminati da, o meglio: attraverso le leggi evolutive) sono unici e specifici.
Ecco perché si può affermare che A e B, il cervello e il “suo” ambiente, sono indissolubilmente intrecciati: non ci sono due entità, non c’è un doppio livello di esistenza, ma una sola indivisibile entità, all’interno della quale il dialogo tra A e B, tra il cervello e il suo ambiente, rimodella di continuo, a ogni nuovo input percettivo, il paesaggio del vissuto costruito nelle precedenti esperienze.
Per questo l’ambiente va pensato e configurato come una serie distinta di livelli di realtà, reciprocamente autonomi: ignorando uno di essi si perde qualcosa di essenziale: “[…] tutti i livelli di spiegazione sono necessari per afferrare una data situazione […]. I livelli di spiegazione operano insieme come strati di una torta, per cui è impossibile coglierne appieno il sapore ignorando gli strati superiori e considerando esclusivamente la base”[14].
4. Quarto presupposto: il linguaggio come scambio che esige un contesto comune
Se accettiamo queste premesse, che oggi sono al centro dell’interesse e dell’analisi della ricerca scientifica un po’ in tutti i campi, dobbiamo altresì convenire che il linguaggio non instaura mai una relazione primaria e originaria con l’ente, non è mai uno scoprire qualcosa, in quanto “l’ente dev’essere già disvelato perché sia possibile un’asserzione su di esso”[15]. Ogni enunciazione, pertanto, si fonda su una comprensione preventiva, in quanto presuppone comunque un aver-a-che-fare-con: “Il carattere primario dell’asserzione è la apofandiz. Tradotto letteralmente questo termine significa: il manifestare qualcosa, il lasciar vedere qualcosa (fainedJai), a partire da se stesso (apo). La struttura fondamentale dell’asserzione è la manifestazione di ciò su cui essa verte. Ciò su cui verte l’asserzione, ciò che primariamente è inteso in essa, è l’ente stesso. Pertanto, quando io dico: ‘la lavagna è nera’, io non asserisco nulla intorno a rappresentazioni, ma faccio un’asserzione su ciò stesso che è inteso. Ogni ulteriore momento strutturale dell’asserzione risulta determinato da questa funzione fondamentale, dal suo carattere di esibizione. Ogni momento dell’asserzione è determinato dalla struttura apofantica “[16].
Questa struttura significa che l’ente considerato nel discorso viene mostrato, piuttosto che fatto oggetto di rappresentazioni attraverso l’enumerazione delle sue proprietà. Gli “oggetti” del discorso vengono disvelati, esibiti e mostrati, e diventano comunicabili solo dopo essere stati assoggettati a queste funzioni primarie ed essere divenuti parte di uno sfondo comune di comprensione , che è dunque un risultato, il punto di arrivo di un processo, e non un punto di partenza: “L’asserzione, in quanto espressa, è comunicazione. Anche il carattere della comunicazione dev’essere compreso apofanticamente. Comunicazione non significa una trasmissione di parole o di rappresentazioni da un soggetto ad un altro, come se avvenisse uno scambio reciproco tra gli eventi psichici dei diversi oggetti. Che un esserci comunichi con un altro esprimendosi significa che, quando asserisce qualcosa esibendola, esso spartisce con gli altri esserci lo stesso rapporto di comprensione nei confronti dell’ente su cui verte l’asserzione. Nella comunicazione e per mezzo di essa un esserci perviene insieme agli altri, i destinatari, nel medesimo rapporto ontologico nei confronti di ciò su cui vien fatta l’asserzione, su cui verte il discorso. La comunicazione non è una riserva di proposizioni accumulate, ma dev’essere concepita come una possibilità grazie alla quale ognuno giunge insieme all’altro nella stessa relazione fondamentale nei confronti di quell’ente che risulta disvelato allo stesso modo”[17].
Winograd e Flores, nel loro ripensamento delle basi e delle prospettive dell’Intelligenza Artificiale, partivano proprio da premesse e presupposti del tutto analoghi a quelli heideggeriani. Anche essi, infatti, partono da un’idea del linguaggio come scambio che presuppone la disponibilità di un contesto comune a chi parla e a chi ascolta e si colloca su uno sfondo di assunzioni e di presupposizioni condiviso dai dialoganti, quale spazio di possibilità che consente l’ascolto di ciò che viene detto e la comprensione di ciò che viene taciuto. Da questo punto di vista la sua funzione primaria e costitutiva non è quella di trasmettere informazioni già predisposte e bell’e pronte, bensì quella di indurre una comprensione o “ascolto” tra persone che condividono un background di conoscenze, interessi e abitudini, generato dalla tradizione a cui appartengono e dal contesto in cui sono “gettati”. In questa prospettiva il dominio di spiegazione più appropriato all’interno del quale inquadrare il linguaggio è quello delle azioni e delle interazioni umane : “Un’espressione è un ‘atto linguistico’ che ha delle conseguenze per i partecipanti, conduce ad altre azioni immediate e ad impegni per un’azione futura”[18]. Questa caratteristica del linguaggio, questa sua funzione consistente nel creare una fitta rete di impegni reciproci evidenzia come la verità sia “ben lungi dall’essere l’unica proprietà semantica che ha importanza”: nella conversazione quotidiana “molti atti linguistici -come le domande, i comandi, le interiezioni, ma anche molti motteggi ed arguzie- non sono né veri né falsi”[19]. E’ infatti evidente, come già avevano sottolineato J.L. Austin e J.R. Searle nella loro analisi del linguaggio come insieme di atti significativi messi in atto da chi parla in situazioni interattive, che ordini, richieste di fare qualcosa (atti direttivi), promesse (atti commissivi), dichiarare due persone marito e moglie (atti dichiarativi) o scusarsi per qualcosa (atti espressivi) non possono essere considerati espressioni aventi un valore di verità. Ma anche gli atti assertivi, che pure sono inseribili in quella dimensione di valutazioni che include il vero e il falso, comprendono un ulteriore impegno sul fatto che la conoscenza di quanto asserito proviene dalla propria personale esperienza. Tutti questi atti, dunque, sia pure in termini e con gradi diversi, creano impegni , in quanto chi parla impegna se stesso sulla intelligibilità, verità, sincerità e appropriatezza di quello che dice. Ma l’impegno non può essere unilaterale: anche chi ascolta deve a sua volta impegnarsi nell’attività di comprensione e di interpretazione. In questo senso “l’importanza essenziale del punto illocutivo è la specificazione del significato in termini di modalità di impegno prese tra chi parla e chi ascolta, dato che entrambi partecipano alla conversazione”[20].
Da questo punto di vista, e proprio per le caratteristiche e le funzioni fondamentali, di carattere eminentemente sociale, che vengono attribuite al linguaggio, la situazione problematica ideale dalla quale partire per specificarne la natura non è quella della “presa di decisioni” in cui è impegnata una mente riflessiva solitaria, cosciente e razionale, che studia complesse alternative e si vale di tecniche sistematiche di valutazione considerate astrattamente. Occorre invece prendere le mosse proprio dalle organizzazioni, considerate come reti di scambi interattivi e di impegni reciproci, fatte principalmente di promesse e richieste che si sviluppano tra i membri che le compongono. All’interno di questa situazione la condizione chiave è quella della risoluzione che, a differenza della presa di decisioni cosciente e razionale, è già sempre orientata verso una certa direzione di possibilità: il pre-orientamento di possibilità , “che scopre uno spazio di azioni possibili nascondendone altre”[21] e che consente a chi si trova in una situazione di irresolutezza, cioè in una situazione nella quale ci si chiede: “che cosa bisogna fare?”, di risolvere una situazione problematica.
Questo processo, in virtù del quale non solo il linguaggio, ma anche il pensiero si presentano come strumenti interattivi, tesi alla costruzione di uno sfondo il più possibile condiviso tra soggetti che partono da punti di vista magari profondamente diversi, pone problemi nuovi che hanno stimolato più ambiti (filosofia della conoscenza e dell’azione, logica, informatica, economia) a studiare, a partire dagli anni ’80, modelli atti a rappresentare l’interazione di più agenti, capaci sia di conoscere, sia di agire. In tali contesti risulta essenziale sviluppare un’articolata strumentazione razionale, che permetta a questi agenti di rappresentare conoscenze, di eseguire inferenze, di applicare diverse modalità comunicative e, infine, di pianificare azioni, in quanto singoli, ma anche in quanto gruppo con i connessi problemi di coordinazione. E’ in questo senso ad esempio che vanno le ricerche che Derrick De Kerckhove, allievo ed erede culturale di Marshall McLuhan, dedica a quelle che egli chiama le forme di “intelligenza connettiva” . In seguito a questi sviluppi il pensiero diventa sempre più una forma di connessione e collaborazione tra persone diverse, il risultato di una condivisione con la famiglia, con l’impresa, con gli amici ecc;, cioè un fenomeno di gruppo[22] .
L’importanza e l’attualità di questo nuovo filone di ricerca sono confermati anche dallo sviluppo, nell’ambito della logica formale, di teorie sistemiche per sistemi multiagente -formalmente dei sistemi multimodali, che possono incorporare anche una dimensione temporale- le quali prevedono la possibilità, da parte di ciascun agente, di ragionare sulle proprie conoscenze e su quelle altrui, e permettono l’identificazione di conoscenze distribuite (distribuite knowledge) o condivise da un gruppo di agenti (common knowledge)[23]. Nelle logiche dei sistemi multiagente, un aspetto molto interessante è l’introduzione di operatori common knowledge mediante i quali si esprime il fatto che tutti i membri di un gruppo di agenti sanno qualcosa, e ciascuno sa anche che tutti gli altri sanno questo, ecc. Vengono introdotti anche operatori di “conoscenza distribuita”, mediante i quali si evidenzia che gli agenti sanno qualcosa “insieme”, cioè una forma di conoscenza collettiva.
5. Quinto presupposto: il paesaggio “lingua madre”
Un altro tassello fondamentale del puzzle che si sta cercando di comporre è la centralità, ai fini dell’acquisizione di un senso profondo d’identità, non solo della lingua, come si è sempre pensato, ma anche del paesaggio. Questa consapevolezza trae origine dell’importanza di non sentirsi “spaesati” all’interno del proprio mondo e la necessità che ne consegue di sapersi orientare all’interno di esso. Dobbiamo imparare a incorporare lo spazio che abitiamo, ma anche quello che semplicemente attraversiamo e vediamo.
Lo spazio di insediamento è la prima immagine del mondo, con i volti familiari, che il neonato si costruisce. Emerge così il suo significato come una lingua madre che non decidiamo di apprendere, che non possiamo non apprendere; e non siamo in grado di conoscere altri ambienti se non a partire dai “paesaggi originari”. Ecco perché, come affermano Cepollaro e Morelli[24], il paesaggio è il lessico originario, attraverso il quale veniamo a contatto con i paesaggi della nostra vita, in un continuo scambio con lo spazio del nostro vissuto: “Il paesaggio è come la lingua madre. La sua presenza, tacita o esplicita, riconosciuta o latente, contiene il codice originario della nostra appartenenza e ci invoca a considerarla, oltre i dualismi tra mente e natura”[25]. Il motivo è semplice: non si può non appartenere a un luogo, non si può non dare senso a quel luogo.
Come la lingua madre, il paesaggio è originario: non è solo intorno a noi, ma anche dentro di noi; è il frutto delle nostre proiezioni e lo introiettiamo divenendo quello che siamo nella nostra continua individuazione. Inizia nelle nostre connessioni sinaptiche, laddove prende forma la nostra mente incarnata, situata ed estesa, e giunge fino a dove la nostra immaginazione ci conduce.
Un bambino che nasce elabora il proprio universo interiore in ragione del paesaggio mentale che si costruisce. A spiegarlo, con stupefacente incisività ed efficacia, è Andrej Belyj in un originale e insolito romanzo autobiografico[26], pubblicato a puntate su una rivista tra il 1915 e il 1917 e poi stampato nel 1922, in cui ci fa vedere il mondo dalla parte di se stesso tornato indietro fino al grembo materno, allo stato liquido se non addirittura gassoso, momento in cui lo scrittore colloca la formazione della propria coscienza. Dalla condizione prenatale affiorano i primi ricordi, poi la venuta al mondo come lo scoppio di una bolla, l’io e il non-io, le prime strutture emerse via via dal deforme, allorché non esistevano né distinzione tra “Io” e “Non-io”, né spazio né tempo, la formazione della realtà, il dottore, mamma e papà, la tata, tutto visto con gli occhi di un neonato che cresce fino alla seconda infanzia.
Al centro della narrazione vi è dunque l’autoedificazione della persona, la quale presuppone, innanzi tutto, la costruzione di una solida consapevolezza della propria identità, la capacità di riuscire a percepire l’integrità e l’armonia del proprio esistere, di individuare quello che possiamo chiamare il “centro di raccolta di tutto l’essere”, da cui nasce il suo “moto vitale”, – il suo volere e pensare, la fantasia e le idee, il suo decidere e agire.
Questa fase preliminare richiede una sorta di “ripiegamento in se stessi”, di discesa nelle profondità del proprio essere, alla ricerca del “principio di identificazione” del sé come individuo, come totalità armonica, come unità organica (ontologica, spirituale e morale). In questo stadio, pertanto, l’io è portato a erigere tra se stesso e gli altri un confine che assume la funzione di linea di demarcazione funzionale all’esigenza, primaria in questa specifica condizione, di accentuare uno “stacco” che faciliti, appunto, il riconoscimento e l’approfondimento del proprio “io”. Se non si vuole però rimanere preda del rischio di innalzare una “parete divisoria” tra sé e il resto del mondo, tra sé e gli altri, questa non può che essere una tappa provvisoria del proprio sviluppo, alla quale deve seguire la capacità di abolire i confini dell’io, di uscire da se stesso e di trovare il proprio Io nell’Io dell’altro.
La vita del bambino si sviluppa quindi a partire da un’antinomia radicale: quella tra i due poli metaforici del “liquefatto” e del “rappreso”, dell’”informe” e della “forma”, del “magm”» e della “struttura”, dello “sciame” e dello “schema”. Poi, pian piano, si verifica una metamorfosi, in seguito alla quale lo sciame diviene via via schema: a partire da questo momento il bambino comincia a vivere nel costante, nel divenuto, come prima aveva vissuto nel divenire continuo, inizia a tenere le fila degli eventi, anche se non tutto gli è ancora avvenuto: molto gli avviene, diviene per un istante e subito svanisce.
“La coscienza di me stesso è – pulsazione: penso pulsando; senza parole; le parole si rompono in pulsazioni; e debbo liquefare ogni parola in fruibilità di movimenti; la comprensione è mimica; e il palpitare dei miei pensieri è – danza ritmica; la parola sconosciuta acquista senso nel ricorso del suo gesto; il gesto vive in me; ritrovo il gesto per ogni parola; il mio mondo è fatto di gesti; davanti a me corrono le parole: i papà, le mamme, le Dunjaše, il professore che mi è rimasto impresso in quel periodo (vestito di giallo); e le parole si imprimono nell’animo in un geroglifico cieco; e il senso dei suoni delle parole si sminuzza con la mia anima! – e la comprensione del mondo non è legata alla parola del mondo; e indolente incalza il senso di ogni contenuto verbale; e la nozione s’allarga in una multiformità di sensi incalzanti, come… lo scettro di Aronne; insegue, incalza, muta i significati…
L’interpretazione è il ricorso delle assonanze; la comprensione è la loro danza; la raffigurazione è arte di volare nelle parole; l’assonanza è una sirena”[27].
Un linguaggio, come si vede, fatto ancora di assonanze, di metafore, di associazioni di senso, giochi di parole e di suoni che vengono vissuti nel loro significato attivo, creativo, disalienante, fortemente legato alla corporeità e alla gestualità, perché, come oggi ben sappiamo in quanto ce lo attestano concordemente i risultati delle neuroscienze, il cervello che comprende e il cervello che agisce sono tutt’uno, per cui il rigido confine tra processi percettivi, cognitivi e motori finisce per rivelarsi in gran parte artificioso. La percezione risulta immersa nella dinamica dell’azione, c’è dunque un preciso sincronismo tra agire, pensare e parlare nel quale, come scriveva già Leopardi in una profetica pagina dello Zibaldone, «”sentiamo corporalmente il pensiero”[28] e siamo di fronte a un “vedere con la mano” che considera la percezione un’implicita preparazione dell’organismo a rispondere e ad agire. Ecco perché e come l’ambiente circostante, il paesaggio, diviene lingua di cui fanno parte l’azione-percezione sinestetica dell’intero “corpo”, e non solo di un “occhio che guarda”, e le prime percezioni del soggetto (immagini, suoni, odori, sensazioni tattili) che si sedimentano e si strutturano come una serie di precipitazioni di incontri primari, e perciò originari.
Lo stesso processo viene descritto in modo parimenti affascinante da Andrea Zanzotto nei suoi contributi di diverso respiro dedicati al paesaggio che vanno dagli anni Cinquanta ai Duemila, raccolti dopo la sua morte in un volume[29]. Anche in questo caso a fare da motivo conduttore è il vissuto del neonato: dallo spazio transazionale che si crea con la madre, caratterizzato da un intreccio inestricabile tra la dimensione affettiva e quella cognitiva, emerge la lallazione, il balbettio, il “petèl” (la lingua con cui la mamma si rivolge a lui) che rappresenta quel linguaggio pre-verbale, quindi quella “lingua madre”, dal quale nascerà il linguaggio vero e proprio. Il paesaggio, che investe l’animo umano sin dalla prima infanzia con tutta la sua forza dirompente è una componente fondamentale e imprescindibile di questa lingua originaria. Sulla scia di Lacan[30] e connettendoci, anche in questo caso, alle indicazioni della ricerca filosofica e neuroscientifica possiamo dire che è una lingua che precede l’alfabeto e la grammatica, che si mescola al corpo, ne ha la natura, è lingua della carne, come pasta che è tutt’una con il corpo nell’espressione dell’essere umano in formazione, materia che il linguaggio strutturerà in modo organizzato solo in un secondo tempo.
Il bambino è impregnato dai suoni e dalle parole che sente già nel corpo materno: i primi suoni sentiti dal feto sono il battito cardiaco, il respiro e la voce della madre ed egli trae notevoli vantaggi dall’esposizione a essi. Tali effetti positivi si hanno soprattutto nelle regioni cerebrali associate all’ascolto e al linguaggio. La voce materna si colloca a metà, in una sorta di spazio intermedio, tra i suoni interni e quelli esterni, dato che viene percepita sia come suono esogeno che endogeno, attraverso la trasmissione ossea e gli organi interni. Si instaura così fin dai primi mesi, un dialogo indispensabile come lo sono le sostanze nutritizie.
Interessanti, da questo punto di vista, sono i risultati di una ricerca della Stanford University School of Medicine[31], avente lo scopo di individuare, con la risonanza magnetica, i circuiti cerebrali coinvolti quando si sente la voce materna. Per farlo i ricercatori hanno analizzato le immagini scannerizzate del cervello di 24 bambini tra i 7 e i 12 anni di età, tutti sani, senza disturbi cognitivi e cresciuti dalla madre biologica.
I bambini hanno ascoltato la voce registrata della madre che pronunciava tre parole senza senso. La scelta è stata fatta per evitare che il significato di qualche termine attivasse una serie di circuiti cerebrali, falsando il risultato dell’esperimento. Gli scienziati infatti erano interessati esclusivamente al suono, e non al contenuto semantico delle cose dette dalla madre. Ad altre due donne, madri anche loro ma di bambini completamente estranei allo studio, è stato chiesto di registrare le stesse parola per fare da gruppo di controllo.
Ebbene i bambini non hanno sbagliato quasi mai: è bastato loro meno di un secondo per riconoscere, nel 97 per cento dei casi, la voce della propria madre. I bambini che mostravano un più alto livello di connessione tra tutte queste regioni ascoltando la voce della mamma erano anche quelli con la massima capacità di comunicazione. Un dato interessante anche per comprendere i deficit di comunicazione e interazione sociale, presenti in alcuni disturbi.
“Non avevamo compreso”, spiega Daniel Abrams, primo firmatario dello studio, “che una voce materna può avere accesso tanto velocemente a differenti sistemi del cervello”.
Nella dimensione primaria della parola non è dunque determinante la significazione che essa produce, ma la sonorità carnale, la dimensione materica, fonematica della parola che il bambino, appena venuto alla luce, mescola con le prime percezioni del corpo, in un insieme che si struttura come una serie di precipitazioni di incontri primari del soggetto con il mondo in cui nasce sotto forma di immagini, suoni, percezioni e che è irriducibile alla comunicazione, perché presuppone e implica la dimensione di un linguaggio che porta con sé il corpo che si separa da quello materno e che comincia a immergersi nel paesaggio che lo circonda, che diviene così vera e propria lingua madre. È importante sottolineare che l’emergere di questa consapevolezza dell’importanza del paesaggio come lingua madre è a sua volta legata a un ulteriore risultato fondamentale delle neuroscienze, acquisito di recente: il riferimento al movimento e all’orientamento nello spazio come fattori cruciali per lo sviluppo e la maturazione del senso d’identità. Tappe fondamentali del processo che ha portato alla maturazione di questa consapevolezza sono un’opera di Alain Berthoz del 1997, Le sens du mouvement, nella quale si sostiene che che già in una sua fondamentale opera del 1997 osservava che “la percezione non è una rappresentazione: è un’azione simulata e proiettata sul mondo. La pittura non è un insieme di stimoli visivi: è un’azione percettiva del pittore che ha tradotto, col suo gesto, su un supporto vincolante, un codice che evoca immediatamente non la scena rappresentata, ma la scena che egli ha percepito. La pittura ci tocca perché riproduce all’inverso il miracolo delle immagini dipinte sulla parete di Lascaux. Io guardo il quadro al posto del pittore che vi ha proiettato la sua attività mentale. Il genio è colui che mi guida a percepire come lui”[32].
Una prima, importante conseguenza di questa impostazione è “che il cervello non si accontenta di subire l’insieme degli avvenimenti sensoriali del mondo circostante, ma che al contrario esso interroga il mondo in funzione dei suoi presupposti. Su questo principio si fonda una vera fisiologia dell’azione”[33]. Sottolinea ancora Berthoz: “Il cervello filtra le informazioni date dai sensi in funzione dei suoi progetti. I meccanismi di questa selezione devono ancora essere compresi; allo stato attuale si conoscono solo alcune forme di selettività. In altre parole, bisogna capovolgere completamente il senso in cui si studiano i sensi: bisogna partire dall’obiettivo perseguito dall’organismo e capire come il cervello interroga i recettori regolando la sensibilità, combinando i messaggi, prespecificando i valori stimati, in funzione di una simulazione interna delle conseguenze attese dell’azione”[34].
L’importanza e la priorità «dell’obiettivo perseguito dall’organismo» è confermata da una serie di esperimenti con le scimmie in cui gli stessi neuroni premotori dell’area F5 sono stati registrati mentre l’animale afferrava oggetti con una pinza che, per la sua particolare conformazione, la obbligava a eseguire movimenti della mano opposti a quelli normalmente impiegati per afferrare un pezzo di cibo; i neuroni per l’afferramento continuavano a scaricare durante l’afferramento del cibo con la pinza, anche se il conseguimento dello scopo era raggiunto impiegando movimenti del tutto opposti a quelli naturali. Questi risultati dimostrano che ciò che tali neuroni rappresentano/controllano è lo scopo dell’atto motorio e non i mezzi, cioè i movimenti, richiesti per conseguirlo: quindi l’azione, definita appunto come movimento diretto a uno scopo.
Ne è seguita l’idea, sempre più solida e corroborata, che, come sottolinea Vallortigara, “l’unico modo per stabilire se una parte del nostro corpo è nostra è muoverla. […] Questo perché, nel momento in cui l’organismo si muove in modo attivo, diventa fondamentale distinguere i segnali sensoriali che vengono dal mondo là fuori da quelli che sono invece la conseguenza dei movimenti dell’organismo stesso nel mondo”[35].
Tutto quello che si è detto porta a concludere che, per i sistemi viventi s’impone la necessità di essere articolati in una triplice dimensione temporale, con un saldo radicamento nel passato, un piede nel presente e un altro nel futuro e che la persona umana è un sistema complesso metastabile, caratterizzata da un perenne andare e venire tra le diverse dimensioni del tempo che la caratterizzano, che la rendono flessibile, capace di molte identificazioni e dunque di una continua metamorfosi. Proprio a questa sua condizione di metastabilità, di equilibrio instabile e dinamico tra passato, presente e futuro, interpretati e vissuti senza alcuna gerarchia, si deve la comparsa di potenziali inespressi che, pur in presenza dei vincoli che ne condizionano sia la struttura interna, sia la relazione con l’ambiente, rendono la persona un sistema costantemente sul punto di sfasarsi e di aprirsi alle opportunità compatibili con la presenza dei vincoli suddetti.
Questo rapporto tra vincoli e opportunità può essere esposto ipotizzando che ciascuno di noi possa muoversi seguendo una direzione e potendo in modo agente modificare il percorso. Egli si trova però all’interno di una tela di interazioni esterne che non può essere flessa o stirata oltre un certo limite, per cui lo scorrimento nella sua espressione statistica complessiva ha un andamento, il che non contrasta con il fatto che il singolo per mantenere coerenza abbia dei gradi di libertà, nell’ ambito del vincolo direzionale globale.
A questo primo aspetto ne va aggiunto un secondo, che ha una portata epistemologica di enorme rilievo, quello che fa riferimento a ciò che chiamiamo “esperienza” che, secondo le neuroscienze, si forma e si struttura quando lo stimolo percepito dall’esterno non è più presente, quando entra in gioco l’impronta dell’universo interiore, talmente decisiva da far sì che il cervello parli soprattutto con sé stesso, come confermano le nuove tecniche grazie alle quali lo si può vedere mentre si attiva, in particolare una variante della Imaging a risonanza magnetica (MRI) – la MRI funzionale (fMRI) – che consente di realizzare esperimenti ben più completi della camera a positroni, di seguire l’attività del cervello secondo per secondo per ore: “Nel bilancio energetico cerebrale, le risposte alle richieste del mondo esterno, le celebri catene stimolo-risposte care a Pavlov e ai comportamentisti, rappresentano appena il 2% del consumo della corteccia. Il resto corrisponde al mantenimento del nostro mondo interiore: i neuroni e le sinapsi che conservano i nostri ricordi e i nostri pensieri reconditi. È sufficiente contare le sinapsi in entrata e in uscita: persino nella corteccia visiva primaria, le fibre in ingresso provenienti dalla retina rappresentano meno del 10% delle sinapsi totali: il resto forma circuiti top-down, verso il basso o centrifughi, che rimandano verso le aree visive delle predizioni e se ne servono come se fosse uno schermo delle nostre immagini mentali”.[36]
Come scrive in proposito Deutsch: “Consideriamo per esempio gli impulsi nervosi che giungono al cervello dagli organi di senso. Lungi dal fornire un accesso diretto e puro alla realtà, nemmeno loro sono esperiti per ciò che sono davvero, cioè scariche elettriche. Né, in genere, lì sentiamo accadere nel luogo dove avvengono, cioè il cervello: li collochiamo invece nella realtà esterna. Non vediamo semplicemente il colore blu, ma un cielo blu, lontano, lassù. Non proviamo genericamente dolore, ma abbiamo mal di testa o mal di pancia. Il cervello assegna interpretazioni come “testa”, “pancia” e ‘lassù’ a eventi che in realtà avvengono dentro il cervello stesso. I nostri organi di senso, e tutte le interpretazioni che, in modo più o meno conscio, diamo dei dati che ci forniscono, sono notoriamente fallibili, come attestano la teoria della sfera e tutti i giochi di prestigio e le illusioni ottiche. Non percepiamo un bel niente come è in realtà. Tutto è interpretazione teorica: congettura.[37]”
Viene così ribadito che non è l’immagine dell’ambiente osservato a viaggiare dagli occhi verso il cervello, ma solo l’informazione relativa a eventuali discrepanze, a scarti, rispetto a quanto il cervello di attende. A essere rilevante, per la capacità di vedere, è dunque proprio lo scarto, strumento, al contempo, di esplorazione e di controllo, di raccordo tra il senso della realtà e il senso della possibilità, che fa emergere un altro possibile, operante, in continua tensione con l’esperienza e il vissuto, che segna una distanza in virtù della quale si resta sempre aperti all’altro e all’altrove.
6. Sesto presupposto: la “non coincidenza con sé stessi” e l’apertura verso il futuro
Questa apertura verso l’altro e l’altrove comporta una tensione verso il futuro le cui motivazioni e basi sono state esplorate ed evidenziate con grande acume da Michail Michailovič Bachtin, il quale introduce, a questo proposito, le categoria di capacità di orientamento verso il futuro e di “tempo grande”, che vengono da lui definite con precisione nella sua grandiosa opera del 1965 dedicata a Rabelais e alla cultura popolare, in un passo nel quale spiega che cos’è una forma di vita rigida e perché il carnevale sia così significativo e importante per metterla in discussione e rovesciarla. La chiusura nel presente e la rigidità che ne consegue, a suo giudizio, sono l’espressione di quella che egli chiama “la stupida coincidenza con sé stessi”[38], ed è appunto questa la caratteristica che la vita carnevalesca tende a dissolvere.
La “coincidenza (“sovpadenie”) con sé stessi è un concetto di cui egli fa ampio uso in alcuni passi fondamentali in un’altra sua opera, il libro dedicato a Dostoevskij[39], quelli nei quali, approfondendo la lezione del grande scrittore, sottolinea: “Non l’analisi della coscienza sotto forma di un io unico e unitario ma analisi appunto dell’interazione di molte coscienze dotate di uguali diritti e di pieno valore. Un’unica coscienza è priva di autosufficienza e non può esistere. Io prendo coscienza di me e divento me stesso solo svelandomi per l’altro, attraverso l’altro e mediante l’altro. I più importanti atti che costituiscono l’autocoscienza sono determinati dal rapporto con l’altra coscienza (col tu). Il distacco, la disunione, il rinchiudersi in se stessi come causa principale della perdita di sé. Non quello che avviene all’interno, ma quello che avviene al confine della propria e dell’altrui coscienza, sulla soglia. E tutto ciò che è interiore non è autosufficiente, è rivolto in fuori, è dialogizzato, ogni esperienza interiore viene a trovarsi sul confine, s’incontra con altre, e in questo incontro pieno di tensione sta tutta la sua sostanza. È un grado superiore di socialità (non esteriore, non cosale, non interiore). In questo Dostoevskij si contrappone a tutta la cultura decadente e idealistica (individualistica), alla cultura della solitudine radicale e disperata. Egli afferma l’impossibilità della solitudine, l’illusorietà della solitudine. L’esistenza dell’uomo (sia quella esteriore che quella interiore) è una profondissima comunicazione. Essere significa comunicare. La morte assoluta (non essere) è impossibilità di essere uditi, di essere riconosciuti, di essere ricordati. Essere significa essere per l’altro e, attraverso l’altro, per sé. L’uomo non ha un territorio interiore sovrano, ma è tutto e sempre al confine, e, guardando dentro di sé, egli guarda negli occhi l’altro e con gli occhi dell’altro”[40].
Il rapporto di alterità, e dunque di non coincidenza con sé stesso, è pertanto costitutivo dell’io, in quanto non esiste un soggetto rinchiuso e definito nella sua interiorità che poi si apre agli altri. L’io, l’individuo è sempre necessariamente già aperto agli altri, poiché è esso stesso dialogo, rapporto io/altro, che si sviluppa e si costruisce proprio nella relazione e nell’interazione costante con gli altri soggetti individuali e con i soggetti collettivi di cui è componente.
Questo stesso concetto viene da Bachtin trasposto dalla persona all’opera che merita di permanere nel tempo grande, che proprio per questo non può avere un rapporto di “sovpadenie”, di coincidenza con il momento storico in cui è stata scritta, altrimenti rimarrebbe incapsulata e imprigionata in esso e non avrebbe le carte in regola per trascenderlo, sarebbe, se non stupida, banale. La legittimità di questa trasposizione è corroborata dagli appunti degli anni Cinquanta, nei quali egli distingue tra un’“esperienza grande” e un’“esperienza piccola”. Quest’ultima è un’esperienza limitata, povera angusta, egoistica dell’io, del corpo e del mondo, che vale ovviamente sia per la persona, per l’io, sia per le sue opere d’ingegno, per i prodotti del suo pensiero. Invece “nell’esperienza grande, il mondo non coincide con sé stesso (non è ciò che è), non è chiuso e non è compiuto. In esso c’è la memoria, che scorre e si perde nelle profondità umane della materia e della vita illimitata, l’esperienza di vita di mondi e di atomi. E la storia del singolo comincia per questa memoria molto tempo prima rispetto ai suoi atti conoscitivi (al suo “io” conoscibile). […] Questa memoria grande non è memoria del passato (in senso astrattamente temporale); il tempo è relativo in rapporto ad essa. Ciò che ritorna in eterno e ciò che il tempo non restituisce. […]. Il momento del ritorno è stato percepito da Nietzsche, ma è stato da lui interpretato astrattamente e meccanicisticamente. […] Nell’esperienza grande tutto brulica di vita, tutto parla, è un’esperienza profondamente dialogica”[41].
I prodotti della cultura, di conseguenza, si suddividono, a giudizio di Bachtin, in due sottoinsiemi: quelli che coincidono con il proprio tempo e quelli che non coincidono con esso, e proprio per questo sono in grado di dialogare anche con tutte le epoche successive e con interpreti appartenenti a esse, i quali vi trovano contenuti che parlano loro, dicendo cose caratterizzate da una perenne attualità. Se lo sdvig, lo scarto che caratterizza la non coincidenza con il proprio tempo viene meno e si spegne l’opera cessa di essere in sintonia con le fasi successive della storia della cultura.
7. Settimo presupposto: ripensare le nozioni di territorio e di luogo
Tutti questi riferimenti, tratti dai risultati della ricerca scientifica di punta in campi diversi, indicano chiaramente che dobbiamo rivedere e ripensare la nozione di territorio, che non è più una variabile dipendente del sistema economico e politico, come pensava a suo tempo Carl Schmitt, secondo il quale non esistono idee politiche senza uno spazio a cui siano riferibili, né spazi o principi spaziali a cui non corrispondano idee politiche. Giusto e sacrosanto! Il problema è però che cambiando la funzione dello spazio e del tempo dovrebbero, appunto, mutare le categorie del politico, mentre nella situazione geopolitica e ideologica attuale si procede usando ancora categorie politiche del modo di produzione industriale e del suo uso dello spazio e del tempo, senza modificare la politica stessa.
In estrema sintesi per il pensiero della Modernità e la Contemporaneità, i cui caratteri fondamentali su questo aspetto sono stati colti in modo mirabile da Schmitt, i territori sono stati fondamentali sia dal punto di vista della formazione del sistema produttivo ed economico in generale, sia da quello politico, con la formazione dell’idea di Stato nelle sue varie articolazioni, sia per le ideologie di identità e appartenenza, in particolare con l’articolazione nazionalistica degli Stati, appunto, Stati nazionali, fondamentali nelle ideologie del Novecento e sempre presenti ancora all’inizio del nuovo millennio.
Oggi però l’idea funzione territorio sembra decostruirsi e depotenziarsi nel modo di produzione digitale. Come se il territorio stesso non avesse più una propria ragione o una sua funzione all’interno del nuovo orizzonte economico e strategico aperto dal digitale. È davvero così o in realtà si prospetta qualcosa d’altro?
Se nel modo di produzione industriale il territorio era cruciale e strutturale, nel modo di produzione digitale esso assume la funzione di una variabile indipendente, sempre però fondamentale e imprescindibile per quanto riguarda il sistema che si instaura con il digitale. I territori stanno diventando economicamente e socialmente variabili indipendenti, recettori di istanze sociali politiche ed economiche che intercettano valori immateriali, narrazioni e giustificazioni valoriali. Sembrano essere i nuovi soggetti politici che si stanno configurando al di là della tradizionale forma Stato o della forma partito, in modi tutti da riconoscere e ri-pensare, appunto, politicamente.
Il modo di produzione industriale aveva uno dei sui punti di forza (quello forse più potente) nella standardizzazione, visto che la sua produzione macchinista non poteva che essere, e per molti aspetti lo è ancora, ripetitiva. Il mercato ovviamente non poteva che riconoscere e fare propria questa istanza. La standardizzazione ha caratterizzato il mercato verso quella globalizzazione che ha segnato una fase determinata del modo di produzione industriale, quella recente.
Il modo di produzione digitale ha sfruttato alla grande la globalizzazione introducendo però una variante sostanziale: l’insieme di cibernetica, robotica, governo dei processi in digitale e IA, permette sia una produzione standard, sia una per singole produzioni tra loro diverse. Si consideri l’uso della stampante 3D che può essere governata per produrre oggetti standard in continuo, ma anche , sempre in continuo, oggetti uno diverso dall’altro. È sufficiente che il programma informatico che controlla il processo produttivo sia predisposto a questo. Il costo del prodotto standard e di quello singolare sarà pressoché uguali, è questa la novità rilevante di cui tener conto. Ovviamente questo fa si che il mercato (comunque globalizzato) non tenda più solo a diffondere prodotti tutti tendenzialmente uguali, in una sorta di omologazione planetaria del “gusto” che ha snaturato nella fase della globalizzazione industriale le identità dei luoghi, ma si apra un mercato che tende a diffondere non solo l’omologato, ma anche le differenze. Prodotti che vengono cercati per la loro singolarità o quella che oggi viene chiamata eccellenza. Ciò che è rimasto della produzione tradizionale dei luoghi, diciamo ciò che è rimasto del mondo artigianale o anche di alcuni aspetti di quello industriale, può diventare così oggetto di un mercato globale, sempre se la globalità ne percepisce una qualche narrazione. Questo sta avvenendo grazie a internet. Questo fa anche sì che luoghi, aree, territori nazioni, che sono stati marginali, rispetto allo sviluppo della globalizzazione industriale, possono trovare una loro nuova ragione economica e mercantile e persino una rinnovata identità culturale. A questo va aggiunto che nella nuova globalizzazione delle differenze la suggestione che attiva il mercato non è necessariamente e ideologicamente motivata da un qualche interesse o amore delle tradizioni in sé, o dei così detti beni culturali, ma appunto, dalla differenze. Il che significa che il nuovo mercato globale può accogliere e anche ricercare differenze per così dire inventate, non legate a particolare tradizioni, purché anche queste siano narrate. Forse andrebbe ricordato che le tradizioni si possono anche inventare. Questa narrazioni non possono che essere ricondotte a luoghi o all’insieme tra territorio, ambiente, paesaggio.
La Sardegna però, è questo il punto fondamentale, non ha bisogno di inventare alcunché, non si trova nella necessità di andare a caccia di differenze da esibire, perché le possiede in modo indiscutibile. È infatti una cosa, che non può essere trascurata, è stata indicata a suo tempo da Placido Cherchi: “Nella nostra tradizione artigianale sono rimaste forti tracce della stilizzazione bizantina e della modularità islamica: si tratta, io credo, di una condizione che ha giocato un ruolo determinante nel plasmare la cifra più caratteristica della nostra civiltà espressiva, per come la possiamo leggere nelle sue configurazioni più recenti e meno recenti. E se si salta questa mediazione fondamentale, si rischia di non capire più nulla delle ragioni linguistiche connesse al vezzo platoneggiante di cui parliamo o dell’approdo all’astrazione che tale vezzo sembrerebbe aver mediato. Di fatto, per il nostro Novecento, le proposte formali provenienti dalle semantiche astrattiste non hanno rappresentato affatto una novità, se è vero che, per una sorta di retaggio culturale ben ricostruibile, noi eravamo già da tempo sull’onda dell’astrazione”.[42]
Cerchiamo di ricostruirlo, allora, questo retaggio culturale, almeno per i sui aspetti di maggiore interesse e importanza. Com’è noto, nel 534, dopo il controllo dei Vandali, La Sardegna viene riconquistata da Giustiniano e ritorna a far parte dell’impero romano, il cui baricentro si era però spostato da Roma a Costantinopoli, divenendo una delle sette province dell’Esarcato d’Africa. Inizia l’età bizantina, destinata a protrarsi fino al 1000 circa e alla nascita dei quattro giudicati.
L’invasione dei Longobardi nel 568, che muta sostanzialmente il volto dell’Italia, non tocca, invece, la Sardegna, anche se sono state rinvenute nell’isola tracce della loro presenza, documentate dal ritrovamento di diversi oggetti. È comunque a partire dalla mancata invasione longobarda nel 599, quando tentano senza successo di prendere Cagliari, che la storia della Sardegna comincia ad allontanarsi da quella dell’Occidente romano-barbarico, e a diventare realmente bizantina. Nei secoli della “lunga età bizantina”, l’isola vive un corso storico differente rispetto a quello dei territori italici e dell’Occidente in genere. Non viene occupata da popolazioni barbariche né dagli Arabi, non entra a far parte dei domini carolingi e mantiene un’ininterrotta dipendenza politico-amministrativa da Costantinopoli. Molteplici sono i riflessi di questa particolare situazione storica, nell’archeologia come nell’architettura, nell’arte come nella scrittura e anche nella lingua sarda. Anche la Chiesa sarda, e questo, come vedremo, è un aspetto di particolare rilievo ai fini della nostra analisi, segue il rito bizantino orientale ortodosso.
Per quanto riguarda la lingua è importante riferirsi alle preziose e dettagliate indicazioni che ci fornisce Giulio Paulis: “Finita nel 534, dopo ottanta anni, la dominazione dei Vandali, la cui lingua germanica non ha lasciato traccia nel sardo, se non forse, nel nome della martora, […] per cinque secoli la Sardegna fu esposta, anche se non sempre con la medesima intensità, all’influsso linguistico e culturale greco bizantino, da prima come provincia della prefettura/esarcato d’Africa e poi come territorio legato all’impero romano d’Oriente, in un periodo di cruciale importanza per la formazione della locale varietà romanza che andava sorgendo dal latino volgare”[43].
Paulis ci segnala, a questo proposito, un’interessante inversione di prospettiva riguardante gli studi sulla lingua sarda e sui suoi rapporti con il lessico greco-bizantino, di particolare interesse ai fini della questione che stiamo trattando: “Sino all’inizio degli anni Ottanta del secolo scorso, sulla scorta delle poche fonti di natura storica, archeologica e artistica allora disponibili, si ammetteva comunemente, con Wagner, che l’influsso bizantino in Sardegna sarebbe stato molto superficiale e ristretto all’ambiente dei gradi più elevati dell’amministrazione imperiale e della gerarchia ecclesiastica. Si riteneva, inoltre, che esso avrebbe interessato soltanto le aree dell’isola – soprattutto quelle meridionali più vicine al principale centro del potere, Cagliari – ove s’incontrano chiese di modulo bizantino, alcune delle quali hanno restituito una serie di epigrafi di alta committenza redatte in medioellenico tra la seconda metà del X e la prima metà dell’XI secolo. Si escludeva, infine, generalmente che la cultura bizantina potesse aver interessato qualche aspetto della vita rustica (come invece, basandosi su tenui indizi, sospettava Terracini) e che fosse mai penetrata nelle zone più interne e montuose della Sardegna.
Queste conclusioni prescindevano dal ruolo che ebbero il greco e l’ideologia politica sottesa al suo impiego nel consentire al volgare sardo di emanciparsi precocemente dal latino come varietà alta di riferimento, per dare origine a una ricca produzione documentaria patrimoniale e giuridica in volgare in anticipo rispetto alle altre tradizioni romanze. Inoltre avevano un difetto: non tenevano conto della potenziale distorsione prospettica conseguente al modesto livello di cognizione del quadro storico e al mancato sviluppo, all’epoca, dell’archeologia altomedievale, disciplina che avrebbe potuto fornire utili informazioni anche sulla vita quotidiana e sull’organizzazione delle campagne. Aspetti, questi ultimi, dai quali, secondo gli storici della società bizantina, è opportuno partire per lo studio delle realtà provinciali dell’impero romano d’Oriente, come la Sardegna.
Di conseguenza venne a crearsi una specie di circolo vizioso, per cui, di fronte alla intravista possibilità d’istituire precisi confronti con materiali lessicali greco-bizantini in rapporto a qualche vocabolo sardo attinente alla designazione di referenti relativi all’orizzonte culturale agropastorale o alla vita quotidiana […] si respingeva o si svalutava l’ipotesi che potesse trattarsi di prestiti bizantini, non già per ragioni di carattere fonetico, semantico o pertinenti alla formazione delle parole, ma con l’argomentazione che il lascito di Bisanzio alla cultura sarda avrebbe avuto carattere soltanto colto e socialmente elevato e non avrebbe raggiunto le zone interne dell’isola. Viceversa, l’assunto secondo cui il livello della cultura bizantina in Sardegna sarebbe stato di tipo esclusivamente elitario e aulico dava adito ad atteggiamenti “iperbizantinisti”, come p.e. il tentativo di derivare taluni nomi personali delle dinastie giudicali del medioevo sardo […].
Il superamento di questa sorta d’impasse è avvenuto, all’interno della linguistica, immettendo nel dibattito scientifico nuovi dati ed elementi di giudizio, con la presa in carico delle indicazioni desumibili sia dal patrimonio topomimico e dalla storia del lessico fitonimico, settori d’indagine rimasti entrambi ai margini degli interessi scientifici di Wagner, sia dalla ricostruzione della vicenda semantica di alcune parole, attribuibile agli effetti dell’irradiazione culturale di Bisanzio sulla società sarda altomedievale. E poiché da qui vengono elementi di una certa novità rispetto al quadro tradizionale delle conoscenze, quale è rappresentato in genere nella manualistica più diffusa, ci soffermeremo in particolare sull’illustrazione di questi aspetti […] per mostrare che l’influsso di Bisanzio in Sardegna, pur manifestando le caratteristiche di una “bizantinizzazione” culturale piuttosto che di una “ellenizzazione” linguistica, non di meno riuscì a raggiungere con qualche elemento lessicale, oltre che con l’onomastica personale, anche il mondo rurale e le aree più interne dell’isola, grazie soprattutto all’impatto sul territorio dell’esercito e della Chiesa. Ciò è vero segnatamente per l’azione cristianizzante esplicata dalla Chiesa orientale, con riferimento alla quale l’analisi linguistica permette di distinguere tra il livello del cristianesimo istituzionale, sancito dai canoni conciliari e sinodali, e il livello del cristianesimo popolare, socialmente marcato e anomalo rispetto a quello istituzionale”[44].
Dunque la Sardegna, oltre a essere stata, fin dalle epoche più remote della sua storia, al centro del Mediterraneo, culla della nostra civiltà, alla cui cultura ha fornito gli importanti apporti che sono stati ricordati in precedenza, è anche, per le ragioni appena ricordate, la regione dell’Europa che più di tutte può legittimamente aspirare a presentarsi come il centro delle relazioni, oggi di primaria importanza e particolarmente delicate, tra occidente e oriente, tra Roma e Bisanzio, tra l’Unione europea e il Paese la cui capitale, Mosca, ha sempre rivendicato per sé, il titolo di “Terza Roma”, e cioè la Russia. Alla base di questa rivendicazione sta, com’è noto, l’idea che dopo la caduta di Costantinopoli sotto il dominio turco (1453) spettasse proprio a Mosca raccoglierne l’eredità e diventare punto di riferimento e artefice della missione universale della Chiesa che Bisanzio aveva ereditato da Roma. Questa investitura aveva avuto un primo riconoscimento ufficiale con la proclamazione dell’indipendenza della chiesa russa da Bisanzio con la creazione del patriarcato nel 1589. Fu proprio il patriarca di Costantinopoli Geremia a sottoscrivere l’atto costitutivo del patriarcato in Russia, nel quale ci si rivolgeva allo zar di Mosca con la seguente dichiarazione solenne: ‘Poiché l’antica Roma è caduta in preda all’eresia di Apolinnare[45], e la seconda Roma, Costantinopoli, si trova attualmente sotto il dominio dei turchi senza dio, oggi, pio zar, spetta al tuo grande regno russo, la Terza Roma, il compito di superare per devozione tutti i regni precedenti: e tutti i regni devoti si sono riuniti nel tuo regno, e tu solo ora hai il diritto di essere chiamato imperatore cristiano in tutto l’universo’. Il ‘Codice’ contenente questa dichiarazione fu inserito nel libro canonico della Chiesa Russa (fogli 15 e 26) e divenne parte integrante della confessione di tutto il popolo russo. Con ciò la Russia sentì di aver acquisito il diritto di fregiarsi del sacro titolo di ‘Santa Russia’ e questo ideale di ‘santità’ costituì uno dei capisaldi della concezione del mondo del suo popolo. Per questo ‘non è probabilmente erroneo affermare che l’idea nazionale russa si è manifestata nel modo più chiaro e smagliante nella concezione «Mosca-Terza Roma»intesa nel suo significato escatologico, nel senso cioè che Mosca va considerata custode della purezza dell’Ortodossia universale, poiché non ci sarà una quarta Roma. […] Con la denominazione ‘Santa Russia’ il popolo russo si riferiva alla fede ortodossa, ricevuta da Bisanzio”[46].
Come sostenne nel 1938 in una delle sue lezioni all’Istituto teologico di Parigi A.V. Kartašëv: “la Santa Russia è il nostro gonfalone. L’inoltrarsi nella profondità di questo nucleo costitutivo della nostra anima russa non ha mai cessato di costituire il compito della nostra autocoscienza nazionale. […] La stessa fede nella santa Russia, la convinzione che al di fuori di quest’ultima non vi siano vie di salvezza per la Russia – ecco il nostro fondamentale capitale spirituale, senza il quale noi siamo un nulla”[47].
La missione di cui la Russia era stata in tal modo investita andava interpretata e portata avanti in modo deciso e senza compromessi. A giudizio degli esponenti più intransigenti dell’ortodossia il tragico destino della stessa Costantinopoli, che i russi chiamavano Zar’grad, la città dell’imperatore, era infatti stata una giusta e inevitabile condanna per l’apostasia compiuta nel concilio di Firenze del 1439, dove la chiesa ortodossa che aveva sede in quella capitale aveva scelto di accettare l’unione con la chiesa di Roma, nel disperato tentativo di ottenere l’appoggio delle potenze cattoliche dell’Europa Occidentale contro l’incombente minaccia turca.
Non si fa certo fatica a ravvisare in questi fatti storici aspetti che in qualche modo spiegano – non certo nel senso di giustificare, ma esclusivamente in quello di aiutarci a comprendere – alcune, almeno, delle radici che hanno portato ai tragici eventi di questo nostro tormentato e drammatico presente, con particolare riferimento al conflitto tra la Russia e l’Ucraina. Se si vuole approfondire questa comprensione, con la speranza che ciò possa finalmente portare alla conclusione di questa assurda guerra, anziché condannare a una insensata “damnatio memoriae” l’intera cultura russa, come purtroppo da molte parti si sta facendo, approfondendo ancora di più un fossato che si sta trasformando in una barriera insormontabile che rischia di impedire ogni forma di dialogo, presente e futuro, bisogna al contrario studiarla di più e meglio, cominciare a calarsi in qualche modo nella sua ottica e prospettiva, per cercare di ricostruire il modo di pensare, la strategia e gli obiettivi della Russia e chi la governa e impostare una comunicazione che possa avere qualche speranza di pervenire a un esito costruttivo. Ed è qui, per questo aspetto cruciale, che può tornare in qualche modo utile la funzione di ponte che la storia, con le sue vicende tutt’altro che contingenti e di breve periodo, ha assegnato alla Sardegna. Si tratta di volere e sapere giocare efficacemente le proprie carte.
Oltre a questa differenza c’è, ovviamente, quella fondamentale di essere, senza dubbio alcuno, il territorio che presenta la maggiore densità e concentrazione di testimonianze archeologiche di epoche diverse. I primi esempi di “beni nuragici” si attestano infatti attorno al XVIII secolo a.C., arrivando poi anche al periodo di insediamento punico del VI secolo a.C., senza andare però a esaurirsi del tutto, come testimoniano i ritrovamenti archeologici che dimostrano la convivenza tra le due popolazioni. All’interno di questo vasto arco temporale, si deve in particolare evidenziare come proprio l’edificazione dei nuraghi e il loro utilizzo sia mutato profondamente, partendo da strutture più semplici e “proto-nuragiche” e arrivando ad un abbandono del nuraghe, che tuttavia non determina la conclusione della civiltà e dell’età nuragiche. Oltre ai beni nuragici propriamente detti ci sono altri beni parimenti identitari, riconducibili non alla civiltà nuragica ma al precedente periodo pre-nuragico, quali le domus de janas o le tombe dei giganti. Pur risalendo al periodo neolitico, estendendo così ulteriormente il periodo di riferimento, queste testimonianze rappresentano non solo beni identitari al pari dei nuraghi e degli altri “beni nuragici”, ma si pongono altresì in rapporto diretto con i successivi sviluppi architettonici della civiltà nuragica in senso stretto.
Questa opportunità, che emerge con la “nuova” globalizzazione, può alimentare un fattore fondamentale del modo di produzione digitale, il poter essere quei luoghi o quell’insieme di territorio, ambiente, paesaggio momento di accumulazione e diffusione di intelligenza e creatività collettiva. Perché lo divengano di fatto occorre però riferirsi a una nozione d’ìdentità quale è stata qui proposta sulla base dell’approccio relazionale di Parfit, che non disconosce certo il riferimento al carattere ereditario, anzi in qualche modo lo valorizza, abbinandolo però in modo imprescindibile, come si è visto, all’idea di un processo in divenire, che va costruito di continuo. Inoltre proprio la natura relazionale della nozione di identità proposta esclude che essa possa risultare portatrice di istanze particolaristiche e orientate all’esclusione dell’altro, di ciò che non appartiene strettamente componenti diverse o semplicemente minoritarie, per cui si tratta di una definizione aperta, disponibile a includere tutte le comunità presenti nel territorio, realizzandosi pienamente nel suo significato dinamico.
8. Ottavo presupposto: la valorizzazione dell’implicito e della conoscenza “tacita”
Un altro aspetto dal quale non si può prescindere allorché si parla di identità e dell’incidenza che essa può assumere non solo sul piano culturale, ma anche su quello propriamente politico, è costituito dal fatto che i singoli individui e le collettività alle quali appartengono non possono limitarsi a recepire in modo passivo i caratteri tradizionali tramandati da generazioni e i significati e i valori trasmessi dal territorio e dal paesaggio di cui respirano l’“atmosfera” e il clima. Essi li devono invece non soltanto assimilare, ma farne oggetto di un’elaborazione consapevole.
A questo proposito va evidenziato un altro aspetto decisivo, la relazione tra conoscenza esplicita e implicita (o tacita). Oggi si parla sempre più, non a caso, di “paesaggio cognitivo”, che è anche, ed è sempre più, cognizione, conoscenza incarnata che ingloba e assimila di continuo germi ed embrioni di saperi, alcuni dei quali sono talmente radicati nel contesto dal quale emergono da costituirne una forma specifica di consapevolezza e di riflessione tacita, implicita, che non può essere compiutamente esplicitata, formalizzata e trasportata altrove. Per questo ogni territorio esprime, accanto alle forme di intelligenza condivise, che danno luogo alle fruttuose analisi riguardanti l’intelligenza collettiva o quella connettiva, anche un’intelligenza sua propria, che lo contraddistingue e ne fa qualcosa di unico, che va preso in esame, soppesato e valutato sulla base della qualità del suo livello conoscitivo intrinseco e incorporato, che ne costituisce il carattere competitivo. Il paradigma della modernità, come detto, si basava su un processo di trasformazione della conoscenza tacita (naturalmente situata) in conoscenza esplicita (potenzialmente universale). È evidente che tale trasformazione ha connotato tutta la storia dell’industria, dalla fabbrica di spilli di Adam Smith all’organizzazione scientifica di Frederick Taylor, dalla catena di montaggio di Henry Ford agli attuali sistemi computerizzati di automazione e integrazione dei processi.
Tuttavia, la conoscenza esplicita si alimenta attingendo alla conoscenza tacita, che costituisce dietro di essa l’immensa riserva di vita dell’umani, del pianeta e oltre. Tutte le volte che si è pensato che la conversione in conoscenza esplicita potesse essere totale e risolutiva, si è andati incontro a fallimenti e cocenti delusioni La consapevolezza della conoscenza tacita e la sua valorizzazione rappresenta la priorità per attraversare la transizione e aprire una nuova, vasta frontiera per le società umane. Su questo crinale si giocherà anche il ruolo dei Large Language Model alla base dell’Intelligenza Artificiale.
La conoscenza tacita è la riserva di conoscenza fondamentale per i processi cognitivi e vitali: pensare di farne a meno comporta la morte del sistema. La vita si basa su un processo cognitivo situato, ambiguo, e sempre incompleto. E questo vale sia per i bionti, i viventi fisici, sia per reti cognitive virtuali.
La mancanza di cura e la diminuzione del valore di tutte quelle attività tipicamente basate sulla conoscenza tacita, tra cui arti, mestieri e altre espressioni creative, con una perdita patrimoniale immensa, con la distruzione di importanti beni culturali strettamente intrecciati con la conoscenza implicita, è il risultato di un aumento di efficienza misurata solo sullo sfruttamento della conoscenza esplicita. La ricerca di questo tipo di efficienza, combinata al criterio di scelta in base ai costi e alla connessa limitazione imposta alle risorse da investire, ha avuto tra le conseguenze, come si è detto, lo sviluppo di discipline e settori standardizzati, favorendo l’insorgere di pozzi di conoscenza specializzata isolati l’uno dall’altro.
Alla specializzazione e alla separatezza dei sistemi produttivi si combina la scelta dell’economia di scala come strada per la competitività. È una scelta indotta da uno specifico insieme di tecnologie, note collettivamente come caratterizzanti le rivoluzioni industriali (prima, seconda e terza). I modelli macroeconomici, concentrati sull’equilibrio produzione-consumo, i modelli di lavoro basati sulla separazione tra pensiero ed esecuzione (corrispondente al basso valore assegnato alla conoscenza tacita), i mercati di consumo omologati e massificati, sono tutte conseguenze del modello produttivo industriale: priorità alla conoscenza esplicita, entità produttive chiuse, separate, e in competizione in un’economia di scala.
La transizione della nostra società verso un nuovo modello valoriale è sintetizzabile proprio nella progressiva dissolvenza delle categorie separate con cui il paradigma della modernità si era strutturato.
9. Nono presupposto: dai “non luoghi” ai “luoghi”
Va a questo proposito ricordato che un sociologo come Marc Augé nella sua opera del 1992 Non-lieux: introduction a une anthropologie de la surmodernité, tradotta in italiano nel 1993[48], proprio elaborando una sorta di antropologia della surmodernità, ha creato un neologismo, “nonluogo”, in contrapposizione ai luoghi antropologici, che ovviamente ha qualche cosa a che vedere con il non spazio. I nonluoghi sono tutti gli spazi che hanno la prerogativa di non essere identitari, relazionali e storici. Se c’è una antropologia è inevitabile che si articoli anche un’etica e una politica; nella postmodernità sarà quella dei nonluoghi, della fluidità come indicherà Bauman, della identità sempre rivista. L’identità soprattutto se elaborata nella memoria collettiva e nella storia è questione eminentemente politica come tutte le forme delle relazioni intersoggettive .
Questo sta già accadendo, se ben interpretiamo il dettato della Convenzione Europea del paesaggio, un trattato internazionale promosso dal Consiglio d’Europa, che riunisce 46 paesi europei, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata dall’Italia con la legge 9 gennaio 2006, n. 14, nella quale si sostiene che “il paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”. E, ancora, esso “concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana sia i paesaggi degradati”.
In virtù di questa definizione la Convenzione impone agli Stati che la riconoscono e ne sono parte della convenzione (art. 5, lett. a), di “riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità”. Questa nozione è stata quindi tradotta e recepita dall’art. 131, commi 1 e 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42 del 2004: “1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell’identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali”.
La critica sociale del nostro tempo, in particolare una figura come Marc Augé, ha più volte fatto presente che il nostro mondo sembra capace di produrre solo luoghi anonimi, senza alcuna identità per una massa sempre più omologata e indistinta: i nonluoghi. La nuova globalizzazione tende a capovolgere questa dinamiche e per alcuni aspetti sembra reintrodurre logiche appartenente a un passato oramai lontano come quella del modo di produzione artigianale che era caratterizzato appunto da prodotti non standard o quando si tratta di elementi ripetuti comunque mai totalmente uniformati. Ovviamente questo vale non solo per i singoli prodotti, ma anche per i luoghi sempre più alla ricerca di una propria singolarità.
I luoghi e lo ripeto l’insieme di territorio, ambiente e paesaggi, con il digitale possono diventare sistemi fluidi, mobili, non necessariamente istituzionalmente predefiniti, capaci di interagire come piattaforma o insieme di piattaforme. Potenzialmente metamorfici, incubatori di intelligenze e creatività collettive tra loro rese interoperabili. La questione è che il sistema di formazione e diffusione dei saperi, delle conoscenze, competenze e delle capacità di innovazione istituzionalizzato e attivato da lungo tempo dal modo di produzione industriale non è adatto, per i motivi esposti, a queste dinamiche. Diventa quindi fondamentale per la riorganizzazione dei luoghi agire sulle forme e i modi del trasferimento e dell’uso collettivo dei saperi.
- Decimo presupposto: un parto gemellare
Sempre a proposito della civiltà nuragica, per capire il contributo che essa ha dato, come protagonista attivo e non come ricettore passivo, alla nascita e allo sviluppo degli stili di pensiero e delle forme di vita dell’intero bacino del Mediterraneo, occorre fare riferimento alle risorse della conoscenza scientifica in tutte le sue articolazioni, in particolare all’archeologia, alla filologia, all’antropologia della cultura materiale, alla storia della mitologia e della filosofia, alla storia dell’arte, alla linguistica, alla paleogenetica.
Un apporto significativo può essere offerto dalla tecnologia e dall’architettura, puntando su un laboratorio e una sperimentazione che si pongano al crocevia tra scienza archeologica e pratiche della costruzione e del restauro applicati all’edificazione, in scala 1:1, di una delle strutture nuragiche più comuni e diffuse, quella trilobata. Si tratta in particolare di capire, attraverso questa costruzione di un “gemello fisico contemporaneo” dei nuraghi antichi, quale siano state concretamente le tecniche di lavorazione delle pietre e a quali tipi di strumenti e di materiali dobbiamo fare ricorso per dare risposte adeguate e convincenti alle questioni poste dalla realizzazione di questi monumenti e dalle straordinarie capacità costruttive di cui essi sono testimonianza. Se ne potranno ricavare risultati di estrema importanza che potranno essere applicati non solo allo studio dei nuraghi, ma anche alle tecniche di conservazione e restauro.
Questo è l’obiettivo dell’iniziativa, nata da un’intuizione di Claudio e Simone Ollanu, originata dal loro contatto quotidiano e operativo con le pietre per la costruzione del Resort “Is Perdas” di Gergei e dal loro incontro con Beatrice Auguadro, laureata in Architettura con indirizzo Tutela e Recupero del patrimonio storico e architettonico, che è stato determinante per fare nascere l’associazione “Perdas Novas”, alla quale si deve l’elaborazione del nucleo iniziale del progetto, di cui sono gli artefici, attorno al quale si stanno oggi mobilitando competenze ed esperienze provenienti da molteplici ambiti disciplinari.
Il senso e le finalità di questa proposta culturale possono essere convenientemente illustrati dal seguente brano: tratto dall’opera di Corrado Fianchino e Manuela Marino Tholos. Analisi della conformazione costruttiva. La favorita di Noto: Trigona o Tholos:
“Il primo organismo architettonico che apre tutti i libri di Storia dell’Arte… è una THOLOS: il miceneo “Tesoro di Atreo”.
Come THOLOI sono i Nuraghi Sardi…
Tuttavia ancora non si conosce in modo certo e univoco come queste tholoi erano costruite, qual era il loro comportamento statico, quali sono stati i processi evolutivi che il procedimento a tholos ha subito e a quali altri procedimenti costruttivi ha dato luogo.
Non esistono “ammassi” murari casualmente ammucchiati, bensì giustapposizione, cioè POSTO e modo GIUSTO di organizzare le pietre per ottenere il risultato finale, costruttivo e spaziale, voluto dalle maestranze umane.
Capire la giusta forma e posizione dei conci per la costruzione della tholos è compito della cultura tecnica di ogni tempo perché solo la comprensione della conformazione costruttiva e del comportamento statico sono conoscenze essenziali per almeno un duplice ordine di motivi:
– Il primo riguarda il RESTAURO di tali organismi. Senza la conoscenza dell’identità costruttiva e statica di essi, si rischia di perderne il valore di testimonianza storica
– Il secondo riguarda il processo evolutivo della tholos e come si è giunti al principio dell’arco e alle volte, di cui ancora non si conoscono, sulla base delle attuali evidenze archeologiche, le fasi evolutive, durate circa mille anni”[49].
Uno degli obiettivi del progetto è quello di far emergere dall’oblìo la Civiltà Nuragica riportandola di diritto nei libri di storia e di storia del pensiero mitologico e della filosofia. Attraverso questa iniziativa si intende fornire un contributo per comprenderne l’identità costruttiva anche in rapporto con le altre civiltà del Mediterraneo, proprio sulla base del riferimento ai fitti scambi tra di esse di cui si è qui parlato, e per “recuperare” o meglio “raccontare” quel patrimonio immateriale di saperi che in epoca nuragica aveva raggiunto livelli di diffusione e di eccellenza con un patrimonio di più di 10.000 nuraghi. Come sottolinea Giorgio Murru, dopo le piramidi egizie, i Nuraghi sono considerati come le più alte espressioni architettoniche del Megalitismo in ambito mediterraneo, di certo le più rilevanti nel Mediterraneo occidentale, di certo tra le più sofisticate dell’intero pianeta,
Sulla base del quadro generale proposto va sottolineato che in questo progetto a contare e a risultare rilevante non è soltanto il risultato finale al quale ci si propone di arrivare, la costruzione del gemello fisico contemporaneo dei 7-8000 nuraghi che quella grande civiltà ci ha trasmesso, ma l’intero processo di studio, di ricerca, di elaborazione di ipotesi e congetture da mettere alla prova dell’azione pratica e della corroborazione o falsificazione che soltanto essa può fornire in modo convincente, in base a uno dei principi cardine del pensiero di Confucio: “Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco”.
Come ha scritto in proposito Giorgio Murru, direttore del Menhir Museum di Laconi:
“E già! Perché il progetto consiste proprio nell’innalzare dal nulla un nuraghe, un grande nuraghe del tipo “a Tholos” complesso, precisamente “trilobato”, cioè su un impianto planimetrico triangolare con le torri disposte ai punti di convergenza delle cortine rettilinee dai quali sporgono proprio come dei lobi. Al centro della figura si eleva la torre principale, il mastio, aperto sul cortile dal quale traggono accesso anche le tholoi delle tre torri perimetrali.
È una forma canonica quella scelta per riproporre una nuova realizzazione, simile a tanti nuraghi di tal fatta oggi parte integrante del patrimonio architettonico e della letteratura archeologica nuragica, due su tutti, il celebre Santu Antine di Torralba(SS) e il Genna Maria di Villanovaforru(SU). In verità quando mi venne proposta la curatela scientifica del progetto “Perdas Novas” indicai il modello “quadrilobato”, quello con le quattro torri disposte agli angoli di una figura quadrangolare, quello ideale. Come nella maggior parte dei modellini di nuraghe in bronzo o in pietra ma soprattutto nelle pregevoli riproduzioni dei modelli di Mont’e Prama, dove la totalità delle rappresentazioni ripropone questo singolare ed evoluto schema costruttivo. Sarà per la vicina Barumini col suo gigante ‘Su Nuraxi’, il principe dei nuraghi “quadrilobati”, celebre espressione dell’arte costruttiva dei sardi della media Età del Bronzo, riconosciuto tale anche dall’UNESCO nella Conferenza di Napoli del 7 Dicembre 1997.
Sarà perché la pianta quadrangolare è divenuta nel tempo quella canonica per la realizzazione di fortificazioni e castelli, si pensi ai progetti di Francesco di Giorgio Martini(1439-1501) e ai suoi Trattati, quando la forma planimetrica, il rapporto tra torri e cortine, la presenza di barbacani e terrazzi protetti da parapetti, verranno codificati; sarà perché i modelli di Mont’e Prama rispondono perfettamente ai dettami di questi codici e aprono uno scenario interpretativo che non può non imporre una severa lettura. E questo affascina!
Come affascina l’idea della movimentazione di quella massa impressionante di pietrame che inevitabilmente verrà mossa, trasportata e messa in opera seppure, nella prima fase, proprio a fine didattico, verrà realizzata la parte sommitale, quella con le mensole, gli spalti e i terrazzi, cioè quella ormai mancante in tutti i nuraghi ma che proprio nel vicino “Su Nuraxi” di Barumini è ancora possibile osservare in alcuni punti.
Un’opera importante che restituirà finalmente il senso pratico dello sforzo, della fatica, dello studio a monte pietra per pietra, della progettazione, del calcolo. Di fronte ad un nuraghe la prima domanda che viene in mente è: “Come avranno fatto….come avranno trasportato quei blocchi enormi,….come li avranno messi in opera lassù….chissà quanti erano…saranno stati schiavi…e soprattutto perché li hanno fatti?”.
Allora mi immagino questo architetto nuragico che trafelato si sposta da un punto all’altro del cantiere. Urla, vociare concitato, stridore di corde e dei ponteggi sotto il peso immane di animali, uomini e massi enormi, la polvere, la sete….
Quando nel 1995 mi confrontai col rilievo topografico di “Su Nuraxi” due dati su tutti emersero perentoriamente: il primo era numerico, ed era relativo alla quantità di pietrame necessario per la costruzione del “quadrilobo” durante la prima fase costruttiva (1.300 a.C.) e le tre torri d’antemurale. per la quale opera sono state impiegati oltre 4.000 m3 di basalto, in parte raccolto sul versante della Giara, in parte cavato sul ciglio dell’altopiano basaltico. Se pensiamo che il peso specifico del basalto è di circa 2,5 tonnellate a m3 per movimentare questa massa di pietrame sono stati necessari circa 20.000 viaggi di un carro trainato da due buoi! Tralascio per ovvi motivi il fatto che un secolo più tardi, quando il bastione venne interessato da un ulteriore potenziamento con la fodera di una spessa camicia muraria, l’innalzamento delle mura fino ai 17 metri rispetto ai 12,5 metri originari e il completamento dell’antemurale vennero messi in opera ulteriori 13.000 m3 di massi di basalto, circa 75.000 viaggi di un carro!
Il secondo rientra nelle conquiste della scienza delle costruzioni ed è il fatto che per la prima volta in un nuraghe complesso il volume dei vuoti supera le masse murarie piene e in una costruzione “a secco” il tutto sa di straordinario!
Se tutto questo lo moltiplichiamo per gli 8.000 nuraghi censiti allora il fenomeno merita davvero una doverosa riflessione che investe diversi ambiti: economia, organizzazione sociale, demografia, tecnologie, progettazione e calcolo, e una forte radice spirituale e religiosa.
Rimane da cogliere il perché di tanta grandezza. Ma forse, grazie alla collaborazione con altre discipline, alla voglia di condividere questi dati con altri specialisti, di costruire un tavolo permanente di confronto aperto e libero, allora potremo serenamente rileggere i “Primi passi della Filosofia” di Pavel Florianskij senza traballare e cogliere, finalmente, che proprio i nuraghi ci aiutano a capire che è giunto il momento di spostare indietro di almeno 1500 anni l’orologio della Civiltà Mediterranea della formazione della quale i sardi sono stati i protagonisti. Ecco, questo è il senso del progetto “Perdas Novas”[50].
A questo gemello fisico se ne dovrà poi abbinare uno digitale. Diciamo, innanzi tutto, che non si tratta affatto di un’operazione artificiosa e forzata, estranea alla natura e alla funzione degli antichi nuraghi. A corroborare questo convincimento sono i risultati di una recente e importante ricerca su questi monumenti, pubblicata sul portale di NURNET – la rete dei Nuraghi, [51] frutto dell’iniziativa di Roberto Demontis, expert technologist presso il Geographic Information Systems Research Program nel settore Digital Technologies For Aerospace del CRS4, che ha implementato uno sviluppo di layer e tematismi GIS basato sui dati di mappatura e georeferenziazione dei nuraghi in Sardegna, del Geoportale creato da NURNET in accordo con il CRS4[52].
Una delle mappe di visibilità dei e fra nuraghi, sviluppate con le funzioni di geoprocessing, ottiene un “grafo di intervisibilità”: Essa mostra l’intervisibilità tra due nuraghi tramite un arco pesato (con valore). Ciò che numericamente si legge ci dice che dalla sommità di circa il 94% dei nuraghi ancora esistenti si poteva essere in grado di “triangolare” e comunicare visivamente con altri nuraghi vicini entro un raggio di 5 km. In base a questi dati si può ipotizzare la capacità dei Sardi Nuragici di comunicare e scambiare informazioni attraverso una vera e propria “rete di comunicazione delle torri” per mezzo di una sorta di “telegrafo di Chappe” [53]ante litteram.
10. Decimo presupposto: la valorizzazione dell’implicito e della conoscenza “tacita”
Si sarebbe quindi di fronte alla dimostrazione scientifica di una teoria “rivoluzionaria” che potrebbe risolvere l’enigma su cui da tempo tanti archeologi si interrogano, ovvero quale sia stata la funzione e la necessità che ha portato i nostri antenati a costruire oltre 10mila nuraghi in Sardegna.
L’articolo pubblicato su NURNET cita, allo scopo di far luce proprio su questo quesito irrisolto, varie fonti, tra cui un altro interessante articolo intitolato “Dell’origine, funzione e utilizzo dei Nuraghi” scritto da Marco Chilosi, sempre sul medesimo sito nel 2018,[54] che a sua volta rimanda a diverse altre fonti. In esso è scritto:
“Se quando sorsero i Nuraghi, le foreste erano lussureggianti e ricoprivano gran parte dell’Isola, era estremamente difficile lo spostamento degli abitanti, anche a causa della conformazione aspra e montuosa di gran parte del territorio. La costruzione ed utilizzo di percorsi, sentieri e strade era difficile da realizzare e mantenere in un contesto geografico così complesso, impedendo lo scambio di comunicazioni necessario per lo sviluppo di una società avanzata ed in espansione demografica come quella Nuragica, coesa culturalmente e politicamente, capace di navigare, commerciare nel Mediterraneo, ed anche temibile potenza militare”.
Sulla dimensione delle foreste sarde prima dell’indiscriminato taglio avvenuto in epoche recenti si rimanda agli studi dello storico Antonello Mattone (STORIA D’ ITALIA” Le Regioni: La Sardegna” Einaudi 1998), dell’antropologo Fiorenzo Caterini (Colpi di scure e sensi di colpa. Storia del disboscamento della Sardegna dalle origini a oggi, Delfino 2013), della botanica Simonetta Bagella (People and Nature, Ecology meets archeology: Past, present and future vegetation-derived ecosystem services from the nuragic Sardinia (1700-580 BCE), nei quali si evocano i tempi antichi in cui la Sardegna era ricoperta di foreste originarie e millenarie.
È interessante ricordare, come si fa nel primo contributo su NURNET citato, che nel 2011 era stato pubblicato su ‘Cagliari Art Magazine’,[55] testata online diretta da Domenico Di Caterino, un articolo che ipotizzava esattamente le stesse cose su cui CRS4 e NURNET stanno lavorando oggi, spingendosi anche oltre.
Si intitolava “Diecimila Torri: la civiltà nuragica come un social network”: da oltre un anno non è più disponibile sul portale che lo aveva ospitato a causa di un attacco hacker che ha causato la perdita di dati. È stato ripubblicato[56] per dar modo a chi è interessato ad approfondire questo tema di verificare le ipotesi proposte già allora. Si tratta di un pdf ampio e dettagliato, ricco di teorie senza alcuna presunzione di carattere scientifico, storico o archeologico.
In esso veniva sostenuta una tesi così sintetizzata:
possiamo ipotizzare che i nostri nuraghe siano un arcaico esempio di Small World Network, ovvero una rete “piccolo-mondo” di comunicazione a sviluppo casuale. Il vasto e complesso “network sociale” creato dai nostri antenati prevedeva di utilizzare le migliori tecnologie del loro tempo con la costruzione di torri di trasmissione secondo regole ben precise. Un Nuraghe doveva sorgere in un luogo con molte possibilità di “triangolazione visiva” con almeno altri 2 nuraghi vicini. Questo allo scopo di creare collegamenti ridondanti e intersecantisi fra loro per garantire uno scambio di comunicazioni in ogni condizione. Anche in caso di interruzione o scomparsa di uno o più rami di collegamento. Se ci pensate si tratta esattamente della stessa logica infrastrutturale e paritetica dei nodi dell’attuale rete internet. Ogni nuraghe era quindi un nodo di accesso alla rete e un “punto di presenza” ovvero in pratica un POP (Point of presence). Alcuni particolari nuraghi, per la loro posizione, assumevano caratteristiche di quelli che si possono definire veri e propri HUB per la concentrazione, ricezione e replica uno a molti delle trasmissioni. Come nelle reti moderne P2P il loro uso doveva essere per forza ibrido e aveva scopi di scambio delle informazioni o controllo del territorio, a fini militari, sociali, economici o religiosi. Per potersi scambiare delle informazioni attraverso una rete “molti a molti” di questo tipo, non era sufficiente un semplice codice morse. Doveva esistere una sorta di protocollo, in grado di riportare all’interno del messaggio, quale fosse il mittente e chi dovesse essere il destinatario. Un sistema appunto molto più vicino al codice di segnalazioni visive utilizzato da secoli in tutte le marine militari e civili. Quindi stiamo parlando di una rete di comunicazione della civiltà nuragica che anticiperebbe di oltre 3mila anni non solo l’attuale rete internet, ma anche il codice binario e la logica di scambio di informazioni delle moderne telecomunicazioni che utilizzano suite di protocolli di comunicazione come il TCP-IP.
Ma, a parte queste ipotesi, estremamente suggestive e da corroborare ulteriormente, il gemello digitale, abbinato a quello fisico, risponde allo scopo di riproporre l’intero processo che riguarda la costruzione di un nuraghe: le ragioni della collocazione, i riti di fondazione, gli strumenti utilizzati in quel tempo, il cantiere con le sue procedure e tutto ciò che animava quell’atto costruttivo.
Per esemplificare la logica di questa combinazione “gemellare”: lo scopo e l’obiettivo non si risolvono nel momento in cui il nuraghe sarà compiuto, ma fanno riferimento all’intero percorso complesso (culturalmente, antropologicamente e socialmente) che diventa il vero elemento attrattore. I visitatori possono venire nel cantiere non solo per vedere come è fatto il gemello fisico, ma come si faceva a farlo, la comunità che abitava attorno a esso e le forme di vita e gli stili di pensiero che animavano l’intero ambiente, tutti aspetti ricostruibili nella dimensione digitale. Il cantiere così al limite potrebbe non finire mai, o se finisse potrebbe generarne uno successivo, per una conoscenza aperta e continua dell’intera civiltà nuragica e del suo fantastico mondo di pietra, e non solo. Vanno in proposito ricordate le considerazioni proposte sul rapporto tra cose e non cose, insieme al fatto che tutte le tecnologie del digitale ci permettono di indagare in vario modo non solo le dinamiche dei saperi espliciti, ma anche quelle dei saperi impliciti. In altri termini, c’è indubbiamente una storicità ancorata a ciò che si rende o rendiamo esplicito (oggettivo, cioè formalmente e razionalmente comprensibile), ma oggi c’è anche una capacità di comprendere, che possiamo definire parastoriografica, quell’implicito che caratterizza la relazione tra la capacità cognitiva, il fattuale, l’ambiente e le condizioni di possibilità. Come per altro sta facendo, da tempo, l’archeologia sperimentale. Questo è uno dei modi per provare ad avvicinarci alle molteplici condizioni antropologiche e ambientali che chiamiamo civiltà con i loro specifici linguaggi, valori, simboli, caratteri, singolarità. Per raggiungere questo obiettivo possono essere straordinariamente efficaci procedure o tecniche digitali come il gemello digitale, appunto, o il metaverso. Il primo permette di indagare e rielaborare strati di senso attorno a singoli oggetti o a un loro insieme (cioè il gemello digitale non è una semplice copia di un dato di realtà, ma lo incrementa e lo arricchisce, come evidenzia il fatto che si stanno costruendo gemelli digitali di scrittori celebri – il primo è Stendhal –dove si fanno confluire non solo la loro biografia, le loro opere, ma tutte le diverse letture e interpretazioni che ne sono state date); il metaverso, dal canto suo, permette con l’interazione di internet di vivere (rivivere/convivere) e quindi di indagare (riprodurre, analizzare, deostruire e ricostruire con una sorta di stratigrafia del senso e dei sensi) su mondi replicati virtualmente. Siamo così di fronte a un prodotto dell’immaginazione produttiva che è l’esatto contrario del proposito di ritirarsi dal mondo. Attraverso il metaverso e il gemello digitale si attiva una strategia dello sguardo, un diverso modo di guardare al mondo che non ha il significato di un colpevole cedimento, di un diniego radicale nei confronti della dimensione ambientale, storica e sociale, ma al contrario costituisce il processo più ricco e potente di cui possiamo disporre per armonizzare senso della possibilità e senso della realtà, immaginazione e percezione. Questo tipo di strategia è resa ancora più efficace dall’affiancamento, al gemello digitale, della costruzione fisica (reale) di un nuraghe, abbinando così in modo inedito l’effettuale al virtuale e facendo in modo che queste due dimensioni si sostengano e si arricchiscano a vicenda.
Gemello digitale e metaverso potranno così essere quell’in più in digitale che ci permette di avere a disposizione non solo l’oggetto fisico ma anche tutte le stratificazioni emotive , logiche, procedurali e costruttive che lo caratterizzano potendo offrire tutto questo in digitale (quindi sia in presenza che in remoto), a utenti vicini e lontani che possono a loro volta manipolare e indagare (sempre in digitale), in conformità ai loro specifici interessi o piaceri, le dinamiche dei modelli virtuali. Ciò significa personalizzare l’offerta per i visitatori, calibrandola sulle diverse esigenze, e mettere lo studioso di scienza delle costruzioni di qualsiasi parte del mondo in condizione – attraverso il suo computer – di confrontare e manipolare il modello con costruzioni analoghe, coeve o meno nel suo paese, così come ogni turista, indipendentemente da dove proviene, potrà vivere nel metaverso l’esperienza di entrare nello spazio nuragico. Questa esperienza virtuale, come è stato ampiamente dimostrato nel caso dei musei digitali, induce il desiderio di un più diretto contatto con la realtà, cioè spinge il visitatore virtuale a venire veramente in Sardegna, approfondendo direttamente la conoscenza della sua storia, della sua cultura e di tutti gli aspetti che la caratterizzano e la rendono unica.
Gemello digitale e metaverso potranno anche aiutarci a simulare al meglio le condizioni di esistenza e le forme percettive degli uomini e delle donne che costruirono quella realtà. Forse così possiamo avvicinarci in qualche modo (e con la discrezione dovuta) al loro modo di essere, meglio di essere stati. E questo certamente può essere parte delle strategie della scienza e quindi di alcuni studiosi, ma a questa ricerca di empatia con un passato remoto può partecipare attivamente una intera comunità alla ricerca della propria identità, e anche chi è semplicemente curioso della straordinarie diversità che offrono le molteplici civiltà con le quali gli umani hanno costruito i loro mondi. Turisti o meno.
Se dovessimo indicare una metafora, diremmo che si tratta di attivare un Theatrum Mundi digitale cioè fortemente inclusivo ed espansivo.
[1] D. Parfit, Reasons and Persons, Oxford: Clarendon Press, Oxford 1984, tr. it.Ragioni e persone, Il Saggiatore, Milano, 1989, pp. 407-408
[2] R.W. Sperry, M.S. Gazzaniga, J.E. Bogen, The neortical commisures: syndrome of hemisferic disconnection, in P.J. Vinken, G.W. Bruyn (eds), Handbook of Clinical Neurology, vol. 4, cap. 4, North-Holland, Amsterdam, 1969
[3] C.A. Defanti, L’identità personale e i disturbi mentali organici, in E. Agazzi, (a cura di), Bioetica e persona, Franco Angeli, Milano, 1993, pp. 196-209
[4] J. Perry, The problem of personal identity, in J. Perry (ed.), Personal Identity, University of California Press, Berkeley, 1975
[5] C. A. Defanti, L’identità personale e i disturbi mentali organici, cit., p. 202
[6] D. Parfit, Ragioni e Persone, cit., pp. 266-267
[7] T. Winograd, F. Flores, Calcolatori e conoscenza. Un nuovo approccio alla progettazione delle tecnologie dell’informazione , Mondadori EST, Milano, 1987, p.74
[8] H.R. Maturana, Cognitive Strategies , in E. Morin, M. Piattelli Palmarini ( a cura di) L’unité de l’homme , Seuil, Parigi, 1974, p. 464, citato in T. Winograd, F. Flores, Calcolatori e conoscenza , cit., p. 76
[9] Barkow, Cosmides, Tooby., La mente adattata: Psicologia evolutiva e generazione della cultura (Kindle 1485-1490).
[10] Ivi, p. 48.
[11] J.J. von Uexküll, Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen. Eine Bedeutungslehre (mit G. Kriszat), Rowohlt, Hamburg 1962; tr. ingl. A Foray Into the Worlds of Animals and Humans: With a Theory of Meaning, translated by Joseph D. O’Neil, University of Minnesota Press, Minneapolis/London 2010, tr. it. a cura di M. Mazzeo, Ambienti naturali e ambienti umani. Una passeggiata in mondi sconosciuti e invisibili, Quodlibet, Macerata 2010.
[12] Lewontin. The triple helix, cit.; E. Yong, An Immense World: How Animal Senses Reveal the Hidden Realms Around Us,, Penguin Random House, Dublin 2022, tr. It. Un mondo immenso. Come i sensi degli animali rivelano i regni nascosti intorno a noi, La nave di Teseo, Milano 2023.
[13] K.N. Laland, F. J. Odling-Smee e M. W. Feldman. 2000. “Niche construction, biological evolution, and cultural change”, ‘Behavioral and Brain Sciences’, 23(1):131-175.
[14] C. Marletto, La scienza dell’impossibile, Mondadori, Milano 2022,, p. 35.
[15] M. Heidegger, I problemi fondamentali della fenomenologia , Il Melangolo, Genova, 1990, p. 201
[16] Ivi, pp. 199-200
[17] Ivi, pp. 200-201
[18] T. Winograd, What Does It Mean to Understand Language ?, ‘Cognitive Science’, n. 4, 1980, p. 229
[19] J. Haugeland, “Introduzione” a J. Haugeland (a cura di) Progettare la mente, Il Mulino, Bologna, 1989, p. 36
[20] T. Winograd, F. Flores, Calcolatori e conoscenza , cit., p. 85
[21] Ivi, p. 180
[22] De Kerckhove ha sviluppato questa tematica soprattutto nelle opere Connected intelligence, del 1997, e The architecture of intelligence, pubblicato nel 2000.
[23] Questi sistemi multimodali sono stati introdotti nel volume di R. Fagin et alii, Reasoning about Knowledge, MIT, 1996, (in particolare c.f.r. il cap. 4).
[24] G. Cepollaro, U. Morelli, Paesaggio lingua madre, Erickson, Trento 2013.
[25] Ivi, p. 13.
[26] A. Belyj, Kotik Letaev, Franco Maria Ricci, Fontanellato (Parma) 1973.
[27] Ivi, pp. 119-120.
[28] G. Leopardi, Zibaldone di pensieri, in Pensieri di varia filosofia e di bella letteratura, (Firenze 18 Sett. 1827), Le Monnier, Firenze, 1921, p. 4288.
[29] A. Zanzotto, Luoghi e paesaggi, a cura di M. Giancotti, Bompiani, Milano 2013.
[30] J. Lacan, Il seminario. Libro XX. Ancora 1972-1973, a cura di A. Di Ciaccia, Einaudi, Torino 2011, pp. 131-133.
[31] D.A. Abrams, T. Chen, P. Odriozola, K.M. Cheng, A.E. Baker, A. Padmanabhan, S. Ryali, J. Kochalka, C. Feinstein and V. Menon, Neural circuits underlying mother’s voice perception predict social communication abilities in children, “Proceedings of the National Academy of Sciences”, vol. 113, n° 22, May 31, 2016, 6295-6300.
[32] A. Berthoz, Le sens du mouvement, Odile Jacobe, Paris, 1997, p. 90, tr. it. Graw-Hill, Milano, 1998, p. 124 (evidenza mia).
[33]Ivi, p. 177 (evidenza mia).
[34] Ivi, p. 253.
[35] G. Vallortigara, Pensieri della mosca con la testa storta, Adelphi. Milano 2021, pp-103 e 107.
[36] S. Dehaene, Face à face avec son cerveau, Odile Jacob, Parsi 2021, tr. it. Vedere la mente. Il cervello in 100 immagini, Raffaello Cortina, Milano 2022, p. 107.
[37] D. Deutsch, The beginning of infinity: explanations that transform the world. Allen Lane. London 2011, tr. it. L’inizio dell’Infinito, spiegazioni che trasformano il mondo, Einaudi, Torino 2013, p.12
[38] M. Bachtin, Tvorčestvo Fransua Rable i narodnaja kul’tura srednevekov’ja i Renessansa, Chudožestvennaja literatura, Moskva 1965, trad. it. di M. Romano, Einaudi, Torino 1979, trad. di M. Romano, L’opera di Rabelais e la cultura popolare, Einaudi, Torino 1979, p. 47.
[39] M. Bachtin, Problemy tvorčestva Dostoevskogo, Kiev 1929, riedito nel 1963 con il titolo Problemy poetiki Dostgoevskogo, trad. it. Giuseppe Garritano, Einaudi, Torino 1968; trad. della precedente edizione del 1929 a cura di Margherita De Michiel, con introduzioni di Augusto Ponzio e Iris M. Zavala, Ed. dal Sud, Bari,1997.
[40] M. Bachtin, Dostoevskji. Poetica e stilistica, Einaudi, Torino 1979, pp. 323-324.
[41] M. Bachtin, “Arte, mondo, memoria, linguaggio”, dalle annotazioni degli anni Cinquanta, in P. Jachia, A. Ponzio, a cura di, Bachtin &… , Laterza, Bari-Roma 1993, pp. 194-195.
[42] P. Cherchi, Intervista su Sciola, a cura di Mascia Manunza, in ID., Il recupero del significato. Dall’utopia all’«identità» nella cultura figurativa sarda, Zonza, Cagliari, 2001, p. 163 (rvidenza mia).
[43] G. Paulis, Greco e superstrati primari, in E. Blasco Ferrer, P. Koch e D. Marzo, a cura di, Manuale di linguistica sarda, De Gruyter, Berlin/Boston 2017, p. 104.
[44]Ivi, pp. 105-106.
[45] Apolinnare di Laodicea (morto verso il 390) cominciò a diffondere, verso il 352, l’idea dell’impossibilità che due elementi completi in sé potessero costituire un’unità vera e propria. Per garantire l’unità di Cristo, a suo giudizio, bisognava dunque che l’elemento umano in lui non avesse alcuna autonomia propria. “Noi confessiamo”, egli diceva, “non che il Figlio è due nature, l’una adorata e l’altra non adorata, ma che è la sola natura del Dio-Logos fatta carne e adorata con la sua carne in una sola adorazione”.
[46] B. P. Kutuzov, Cerkovnaja “Reforma”XVII veka kak idelogičeskaja diversija e nacional’naja katastrofa (La “Riforma” della Chiesa del XVII secolo come diversione ideologica e catastrofe nazionale), “TRI-L”, Moskva 2003, p. 507.
[47] A. V. Kartašëv, Vossozdanie Svjatoj Rysi (La ricostruzione della santa Russia), Imprimerie cooperative Étoile, Paris 1956, p. 19.
[48] M. Augé, Non-lieux: introduction a une anthropologie de la surmodernité, Editions du Seuil, Paris 1992, tr. it. Elèuthera, Milano 1993.
[49] C. Fianchino e M. Marino Tholos. Analisi della conformazione costruttiva. La favorita di Noto: Trigona o Tholos, Aracne, Roma 2018, p. 13,
[50] G. Murru, Il progetto “Perdas Novas”. Costruire un nuraghe ossia un “gemello fisico contemporaneo” di un antico nuraghe.
[51] https://www.nurnet.net/blog/nuove-implementazioni-sul-geoportale-nurnet/
[52] https://www.crs4.it/peopledetails/66/roberto-demontis/
[53] Si tratta di un sistema “ottico” di comunicazioni immediate a distanza, inventato dai fratelli Chappe in Francia alla fine del XVIII secolo, con il quale, mediante “stazioni” poste lungo una linea e opportunamente distanziate, il messaggio veniva trasmesso da una alla successiva, che lo decifrava e lo ritrasmetteva, fino a giungere al termine di questa “linea” predeterminata.
[54] https://www.nurnet.net/blog/dellorigine-funzione-e-utilizzo-dei-nuraghi/
[55] https://www.cagliariartmagazine.it/
[56] https://drive.google.com/file/d/1OO8gGoBJW-zbe1wlGU3KsBXbS1g9_1Ee/view